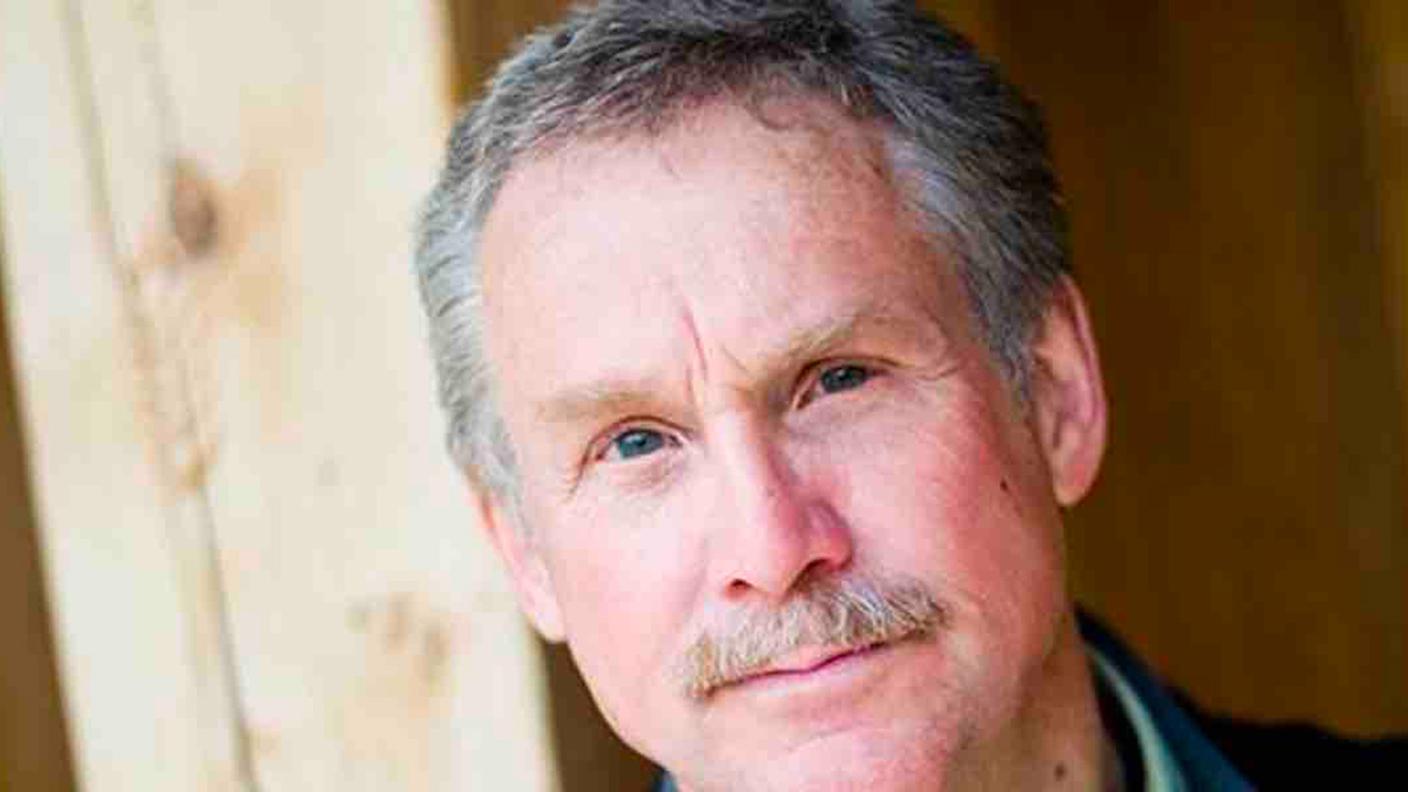“Chi sono io?”: sembrerebbe la domanda più semplice, in realtà è la più difficile e vertiginosa. Perché la risposta non c’è, oppure è possibile fornirla soltanto per sottrazione (viene da pensare al Montale di “Non chiedere la parola”: «Ciò che non siamo, ciò che non vogliamo»). In tempi di nuove angosce e nuovi millenarismi, la domanda assume inoltre la connotazione di una resa dei conti, perché chiedersi “Chi sono io?” significa porsi al cospetto della vita come infinito gioco delle occorrenze e delle eventualità, considerare senza autoindulgenze il pregio ma anche la sventura di vivere nel tempo, il senso del passato e della memoria, le cose che si perdono, il mistero della morte, la crisi irreversibile della ragione. Tutte questioni che Max Frisch non cessa idealmente di rivolgerci con estrema urgenza e attualità, a trent’anni esatti dalla morte.
“Wer bin ich?”, “Chi sono io?”, è la domanda (la “Selbstsetzung”, come l’aveva definita lo stesso Frisch, derivando il concetto da Kant) che si pongono tutti i suoi grandi personaggi, ovviamente senza trovare risposte: Stiller nell’omonimo romanzo del 1954, Walter Faber nell’altro grande romanzo “Homo Faber” del 1957, e poi Theo Gantenbein nel romanzo del 1965 “Il mio nome sia Gantenbein”, Kürmann nel testo teatrale del 1967 intitolato significativamente “Biografia. Un gioco scenico”. E infine se la pone, senza egualmente trovare risposte, il “personaggio” Max Frisch in testi maggiormente riconducibili all’autobiografia come i diari degli anni 1946-1949 e 1966-1971 e il racconto “Montauk” del 1975. C’è tuttavia un personaggio, dal carattere indirettamente autobiografico, che si pone la domanda con una radicalità estrema, spingendosi fino a un punto di non ritorno: il Signor Geiser, protagonista del grande capolavoro della vecchiaia, il lungo racconto “L’uomo nell’Olocene”, pubblicato nel 1979 dopo una lunga e tormentata gestazione durata quasi un decennio. Nel 1992, Manfred Eicher e Heinz Butler ne hanno liberamente tratto l’arduo e coraggioso film “Holozän”, col grande attore svedese Erland Josephson nel ruolo di Geiser.

Il racconto è ambientato in una non meglio precisata valle prealpina, ma è facile riconoscere la Valle Onsernone, dove Frisch aveva una casa nel villaggio di Berzona. Una catastrofe naturale -un diluvio che sembra non avere fine, con relative frane, smottamenti e l’interruzione dell’energia elettrica- ha isolato la valle dal resto del mondo. In un piccolo villaggio della valle c’è l’anziano Signor Geiser: la sua situazione è particolarmente problematica anche perché, a differenza degli altri personaggi di Frisch, che si chiedevano “Chi sono io?” avendo come punto di riferimento un mondo circostante e una (ancorché problematica) vita di relazioni, Geiser non ha più né relazioni, né punti di riferimento. La sua domanda risuona nel vuoto.
Ecco allora che Geiser, un po’ come gli abitanti di Macondo in “Cent’anni di solitudine” di Garcia Marquez, si difende utilizzando come estremo baluardo la memoria, catalogando i fenomeni, utilizzando le parole come argini contro l’erosione della memoria stessa e dell’intera esistenza, contro l’apocalisse che incombe. Ma in un mondo condannato alla fine, dove la natura è sul punto di riprendersi lo spazio che l’uomo le ha colpevolmente sottratto, anche la memoria perde gli appigli e brancola nel vuoto: c’è un momento, diceva Ingmar Bergman, in cui «le parole molto semplicemente svaniscono». Ricordare, catalogare, trascrivere le voci delle enciclopedie, fissare una scansione temporale, tutto sembra allora drammaticamente e grottescamente inutile, come la pagoda di crackers che Geiser tenta di costruire all’inizio della storia: «Si dovrebbe poter fabbricare una pagoda di crackers, non pensare a niente e non udire tuono, né pioggia, né lo sgocciolio dalla grondaia, né il gorgoglio tutt’intorno alla casa. Forse una pagoda non viene, ma la notte passa».
E’ un incipit di importanza decisiva, che Frisch ha spiegato in maniera molto penetrante nel corso di un’intervista del 1984: «Una pagoda è una perfetta e totale immagine del mondo. E il personaggio ci lavora perché teme che il mondo vada perduto. L’insieme esprime quindi il sogno che il mondo dovrebbe essere perfetto, e che noi dovremmo essere in grado di vederlo come un tutto, nella sua evidenza e compiutezza».
Ma il sogno non si avvera, perché il mondo non è più dato nella sua evidenza e compiutezza: «Non basta che il Signor Geiser sottolinei con la sua biro in questo o quel libro le cose degne d’essere sapute; dopo un’ora appena uno se lo ricorda solo approssimativamente; soprattutto i nomi e le date non restano impressi; il Signor Geiser deve scrivere di propria mano su un foglietto ciò che non vuole dimenticare, e poi attaccare i foglietti alle pareti». Geiser riempie le pareti di casa con foglietti e ritagli di manuali, enciclopedie e libri di testo, nell’estremo tentativo di chiamare le cose, per averle con sé fino all’ultimo, per fare in modo che conservino almeno una parvenza di significato: “Chi sono io?”, una volta ancora. Ma non c’è risposta. Nel corso di una lunga escursione in una zona particolarmente impervia, Geiser viene colpito da un ictus che ne limita le facoltà motorie e gli fa avvertire concretamente il senso dell’erosione: la palpebra sinistra è paralizzata, la rima labiale è storta, ma «per il resto non è successo niente».
E’ vero, perché in realtà «non è successo niente», proprio niente. Nel frattempo, la grande pioggia è finita, la natura ha ripreso il proprio corso, anonima e indifferente, la valle non è più isolata (ma da cosa?), eppure l’aria è satura di vuoto, di nulla, di un silenzio assoluto, lacerante, definitivo. I foglietti, i ritagli e gli appunti di Geiser si rivelano allora per ciò che realmente sono: cronaca dell’erosione, catasto del frammentario, lemmi enciclopedici che rimandano a un io e un mondo ormai disgregati, notizie sparse -e non meglio decifrabili- dalla fine del mondo. «Le catastrofi le conosce solo l’uomo, nella misura in cui ne esce vivo; la natura non conosce catastrofi»: a trent’anni dalla morte, Max Frisch ci parla anche -e soprattutto- da questa vicinissima lontananza. Come dice un memorabile passo di “Stiller”: «E’ semplicemente silenzio. Di fronte al dato di fatto della vita e della morte non c’è assolutamente nulla da dire».