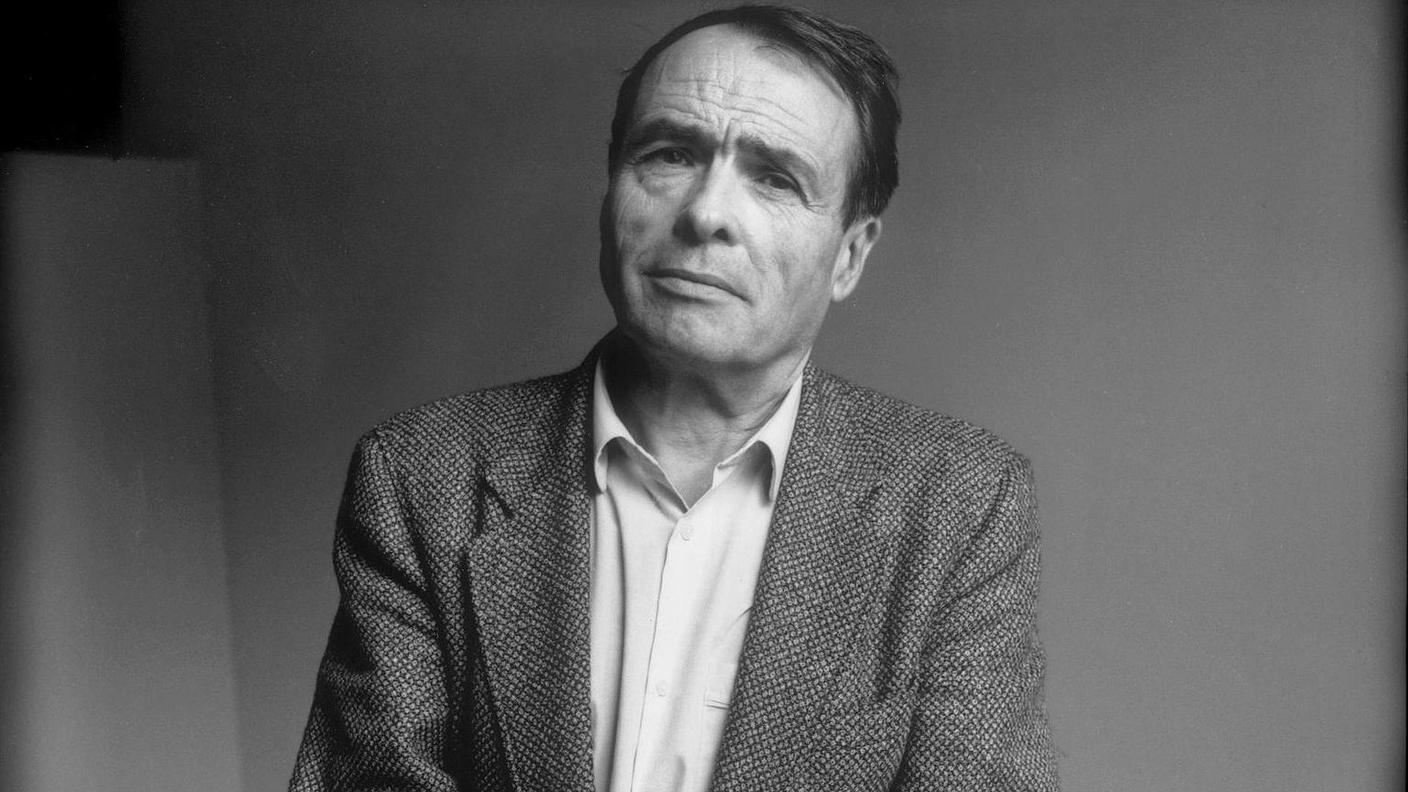La scrittrice Kübra Gümüşay, in Lingua e essere (Fandango, 2021), descrive la lingua come un museo abitato da due tipi di persone: quelle innominate e quelle nominate. Quelle innominate sono «lo standard. La norma. Il metro di paragone». Il museo, mostra le cose dalla loro prospettiva. Non a caso, perché sono loro a scegliere cosa esporre, a dare i nomi e stabilire le definizioni. Esercitano un potere che non sanno nemmeno di avere.
Gli individui nominati, invece, sono «anomalie nella concezione del mondo degli innominati. Non previsti. Strani. Diversi. Talvolta anche banalmente inconsueti. Sconosciuti. Provocano incertezze. Non sono normali». Per questo, le persone innominate li analizzano, li classificano e li riducono a un nome collettivo – “i gay”, “i disabili”, “gli extracomunitari” –, riducendoli a caratteristiche che credono siano tipiche in loro. Li mettono simbolicamente in “teche di vetro”. Non sono più persone, ma esemplari di una categoria “anomala”.
Quando qualcuna di loro prova a uscire da questa teca («una punk col velo o un ballerino classico di colore»), sfidando gli stereotipi, la reazione delle persone innominate è spesso di indignazione e violenza.
Kübra Gümüşay è una “nominata”: turco-tedesca, musulmana, femminista, istruita, indossa l’hijab e sfugge sia alla “norma”, sia alle categorizzazioni stereotipate.
Il fatto è che «al fine di dichiarare universale la propria particolare visione del mondo, i nominanti le assegnano dei nomi: «universale, neutrale, razionale, obiettiva». Ma nulla di questa visione del mondo è universale, neutrale, razionale, obiettiva, e, in ultima analisi, normale: è anzi il prodotto di una precisa visione culturale, nata e accolta dalle persone dominanti in questa società. Persone bianche, di genere maschile, senza disabilità, eterosessuali, neurotipiche (e via dicendo), Fabrizio Acanfora spiega nel suo saggio L’errore. Storia anomala della normalità (LUISS, 2024).
Acanfora ripercorre la storia del concetto di “normalità”, analizzandolo dal punto di vista sociale, politico, medico, psicologico, economico, statistico. Tutto nasce nel diciannovesimo secolo con il matematico belga Adolphe Quetelet e la sua ricerca dell’homme moyen, l’uomo medio. Misurando migliaia di soldati, Quetelet creò un modello statistico basato sulla media, rappresentato dalla famosa “curva a campana” o “gaussiana”. Al centro della curva si trova la normalità, la maggioranza; ai lati le deviazioni, gli errori. Questo modello, nato per scopi statistici, è presto diventato uno strumento di controllo sociale. È qui che che l’errore intrinseco nell’individuo «diviene patologico o mostruoso nel momento in cui la normalità passa a essere anche un concetto medico», sottolinea Acanfora. Da quel momento, la norma ha smesso di essere un semplice dato statistico per diventare un valore a cui conformarsi. Chi non ci rientra viene percepito come differente, sbagliato, anormale.
La normalità, quindi, non esiste in natura. È un costrutto statistico e sociale, peraltro recente, che ha plasmato le nostre vite in modi che spesso non riconosciamo. Il concetto di normalità «ha molto poco a che vedere con naturale», e dipende invece dal tempo e dal luogo in cui viviamo, spiega la sociolinguista Vera Gheno nel saggio (Nessunə è normale (UTET, 2025). Il titolo riprende «Da vicino nessuno è normale», frase attribuita allo psichiatra Franco Basaglia, che riassume perfettamente la sua critica a un sistema che usa la “normalità” per etichettare e isolare.
Il problema è che questa “normalità” non è neutra. È stata costruita su un modello ben preciso: quello dell’uomo bianco, cisgender, eterosessuale, non disabile, neurotipico e di una certa classe sociale – e risente ancora, a distanza di secoli, del concetto di “uomo medio” di Quetelet. Ogni corpo e ogni mente che si discosta da questo modello diventa “altro”, a cominciare da quelli femminili. Come notano Ginevra Bersani Franceschetti e Lucile Peytavin nel saggio Il costo della virilità (Il Pensiero Scientifico Editore, 2023), «essere donna, con tutti gli attributi che le sono associati (dolcezza, sensibilità, istinto materno, ecc.), è stato a lungo visto come una “specificità”».
Le conseguenze sono concrete e, a volte, letali, come spiegano Emanuela Griglié e Guido Romeo nel saggio Per soli uomini. Il maschilismo dei dati, dalla ricerca scientifica al design (Codice, 2021). Pensiamo alla medicina. Per decenni, la ricerca farmacologica e clinica ha usato il corpo maschile come standard universale. I farmaci vengono testati principalmente su uomini, ignorando le differenze biologiche e ormonali. Il risultato? Dosaggi sbagliati, diagnosi mancate e una maggiore mortalità. L’infarto, per esempio, si presenta con sintomi diversi nelle donne, che per questo motivo ricevono più spesso diagnosi tardive o errate.
Lo stesso principio si applica al design. Gli smartphone sono progettati per le mani di un uomo. Le cinture di sicurezza sono testate su manichini maschili, aumentando significativamente il rischio di lesioni per le donne in caso di incidente. Dagli assistenti vocali, che faticano a riconoscere le voci femminili perché troppo acute, agli spazi pubblici, inaccessibili a chi ha una mobilità ridotta, viviamo in un mondo che esclude sistematicamente chi non rientra nello standard.
Cosa succederebbe se iniziassimo a progettare un mondo che non si basa su uno standard unico, ma che celebra la diversità umana? Non si tratta di “includere” chi è “fuori norma” in un sistema che rimane immutato. Come spiega Acanfora, il concetto di inclusione presuppone uno squilibrio di potere tra chi include e chi viene incluso. L’obiettivo è, piuttosto, la convivenza delle differenze: un mondo in cui ogni corpo e ogni mente possano trovare il proprio spazio senza doversi giustificare o adattare. Un museo in cui non ci sono più persone nominate e innominate, ma ogni persona è considerata un capolavoro perché unica, e può scegliere quali nomi, quali etichette usare per sé.
La strada è lunga, ma possiamo iniziarla mettendo in discussione la nostra idea di normalità. Possiamo farlo nelle conversazioni e nelle scelte di ogni giorno. Possiamo pretendere che ogni persona sia prevista, e non solo chi si adegua a uno standard – peraltro irreale e irraggiungibile.
Chiudere il divario di genere in medicina
RSI Info 31.08.2024, 18:00
Contenuto audio