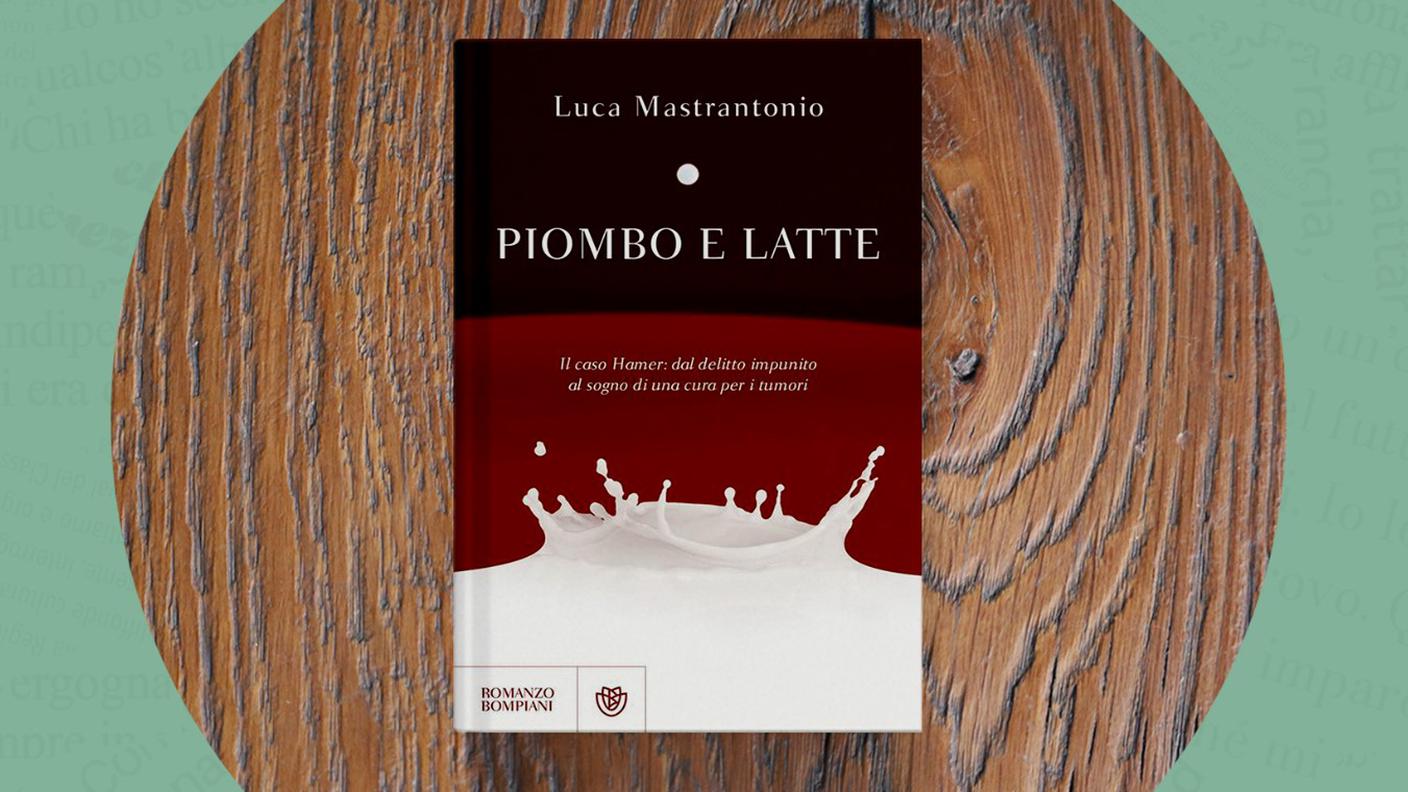Siamo animali e in quanto tali ci muoviamo per l’esigenza di predare, a differenza delle piante che vivono della luce. Ci spostiamo perché dobbiamo predare, e consumare dell’altra vita.
Stefano Mancuso, botanico e neurobiologo vegetale
Non c’è chi non veda come, in questo primo quarto del ventunesimo secolo, la tendenza ad assecondare gli istinti predatori insiti nella nostra specie sia pericolosamente e drammaticamente al rialzo. Un caso esemplare, non l’unico, di questa tipologia di homo rapax, è il presidente Donald Trump: al suono di Drill baby drill, e con la giustificazione a noi serve, sta allungando le mani su territori e acque ricchi di materie prime critiche, minerali indispensabili per la transizione digitale ed energetica. Sono 34, tra cui litio e cobalto, un macro-insieme di minerali e metalli al cui interno figurano anche le cosiddette “terre rare”, i 17 materiali fondamentali per la realizzazione di prodotti di alta tecnologia.
Per fare giusto due esempi: pensiamo all’Ucraina e all’intesa cruciale sui minerali cui è stata vincolata l’assistenza militare americana, trasformando così le terre rare in arma diplomatica e nuova forma di colonialismo; o ancor più alla Groenlandia, isola strategica sotto diversi aspetti. Oltre alla sua posizione geografica, destinata a diventare cruciale con l’apertura di nuove rotte di navigazione dovute allo scioglimento dei ghiacci, vanta un sottosuolo ricchissimo di risorse naturali. Vi si trovano infatti ampie riserve di queste preziose materie prime critiche: cobalto, grafite, litio e nichel (utilizzati, ad esempio, nelle batterie dei veicoli elettrici), ma anche rame, zinco e metalli più rari come titanio, tungsteno e vanadio, impiegati nella produzione di superleghe avanzate. Trump ha minacciato di annetterla agli Stati Uniti, ancora una volta con la frase «Ne abbiamo bisogno, per la sicurezza internazionale».
Sotto la superficie, cosa si nasconde davvero sott’acqua?
Millevoci 09.05.2025, 10:05
Contenuto audio
Non solo Trump: la UE e il Coltan ruandese
Per non attribuire troppo facilmente la corsa alle risorse al solo presidente USA, è bene ricordare che anche altri attori internazionali – tra cui Cina, Russia e la stessa Unione Europea – sono coinvolti in dinamiche a volte tutt’altro che trasparenti. Emblematico, ad esempio, è il memorandum d’intesa siglato dall’UE con il Ruanda per incrementare l’approvvigionamento di materie prime critiche, come il tantalio, indispensabile per la produzione di microchip e batterie per auto elettriche.
Si tratta di un metallo critico che proviene per la maggior parte dalle miniere di coltan, di cui però il Ruanda è sprovvisto: secondo numerosi rapporti del gruppo di esperti delle Nazioni Unite, lo ottiene saccheggiando, per mano del violento ed efficiente esercito dei ribelli dell’M23, la confinante Repubblica Democratica del Congo (dove si estrae circa l’80% del coltan mondiale), in un contesto segnato da violenze e conflitti armati alimentati anche dalla contesa per il controllo delle risorse.
Perciò l’accordo fra UE e Ruanda è stato presto denunciato da attivisti e voci autorevoli come quella di Denis Mukwege, premio Nobel per la pace del 2018: «Quando gli altri parlano di energia verde, per noi quella stessa energia è rossa, coperta del sangue di milioni di congolesi morti».

Estrazione di terre rare in Myanmar, 2022
Anche il Parlamento europeo ha riconosciuto le criticità del memorandum d’intesa siglato tra l’Unione Europea e il Ruanda nel febbraio 2024. In una risoluzione, i deputati hanno denunciato gravi violazioni dei diritti umani – tra cui attacchi indiscriminati, uccisioni e stupri – e hanno chiesto la sospensione immediata dell’accordo. Tuttavia, invece di annullarlo, si è optato per una semplice sospensione. Questo significa che, se tra due anni la situazione sarà considerata “stabilizzata”, l’intesa potrà essere riattivata. Ma, come fanno notare diverse voci critiche, se il Ruanda non possedeva quei minerali 5 anni fa, difficilmente ne disporrà legittimamente in futuro: il rischio che continuino a provenire da saccheggi nella vicina Repubblica Democratica del Congo resta altissimo.
La storia – purtroppo – tende a ripetersi. Lo racconta con forza esemplare lo scrittore indiano Amitav Ghosh nel suo La maledizione della noce moscata (Neri Pozza, 2022), che ripercorre le brutali dinamiche predatorie del passato.
Intervista Amitav Ghosh
RSI Cultura 07.12.2021, 09:50
Oggi cambiano i materiali, ma non le logiche: i minerali e i metalli rari, così cruciali per la transizione tecnologica ed ecologica, rischiano di ridisegnare gli equilibri geopolitici globali, alimentando nuove tensioni, conflitti e alleanze strategiche.
E la corsa all’estrazione non si limita più alle profondità della terra o ai confini del cosmo: si spinge sempre più giù, nei fondali oceanici, dove si celano ecosistemi straordinari, ancora in gran parte inesplorati (uno studio pubblicato su Science Advances rivela che il 99,9% dell’oceano profondo non è mai stato osservato direttamente dagli umani), ma già oggetto di contese e interessi globali.
La corsa allo sfruttamento dei fondali marini
Si sa per certo, infatti, che i fondali sono ricchi dei tanto ricercati minerali critici, in molti casi anche molto più dei giacimenti terrestri. Ecco perché fanno gola a molti. Ed è proprio questo il motivo per cui stiamo per entrare nell’era dell’estrazione mineraria in acque profonde (Deep Seabed Mining), che avviene tra i 4’000 e i 6’500 metri di profondità.
Ma «i fondali marini non possono diventare il Far West del futuro»: così ha ammonito il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, aprendo la Conferenza ONU sugli oceani svoltasi a Nizza lo scorso giugno. Un appello rivolto a governi e industrie, che sottolinea l’urgenza della posta in gioco: il destino delle profondità oceaniche, territori ancora in gran parte sconosciuti, ma già al centro di interessi economici e rivalità internazionali.
Nella dichiarazione finale dell’incontro – il cosiddetto Nice Ocean Action Plan – è stata ribadita con forza la necessità di rafforzare la conoscenza scientifica degli ecosistemi marini profondi e di definire al più presto una regolamentazione internazionale condivisa, capace di prevenire danni potenzialmente irreversibili ai fondali oceanici.
Un tesoro che fa gola
Alphaville 12.07.2024, 11:45
Contenuto audio
In realtà, proprio perché le profondità marine sono così importanti per la Terra, esiste da tempo un’organizzazione indipendente fondata originariamente dall’ONU per coordinare e controllare tutte le attività connesse ai minerali presenti nei fondali marini internazionali oltre i limiti delle giurisdizioni nazionali. Si tratta della Autorità Internazionale dei Fondali Marini (ISA, International Seabed Authority): istituita nel 1994 nell’ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, conta oggi 170 membri (169 Stati più l’UE), ma dopo oltre 30 anni non ha ancora approvato un codice normativo condiviso. Di conseguenza, non sono state autorizzate attività estrattive a fini commerciali. Sono però state rilasciate 30 licenze esplorative a 21 appaltatori, molti dei quali sponsorizzati da grandi potenze come Russia, Cina e Corea del Sud, per operare in aree chiave come la zona di Clarion-Clipperton, l’Oceano Indiano e il Pacifico settentrionale.
Le tecniche di estrazione previste sono il dragaggio del fondale o l’aspirazione dei sedimenti e comportano entrambe seri rischi per gli ecosistemi profondi: habitat unici formatisi in migliaia di anni possono essere danneggiati irreversibilmente. Basti pensare che le tracce lasciate da una semplice esplorazione nel Pacifico nel 1979 sono visibili ancora oggi, e l’ecosistema non si è ancora del tutto rigenerato dopo più di quarant’anni.
https://rsi.cue.rsi.ch/info/ambiente/In-fondo-al-mare-una-miniera-o-una-riserva-naturale--2051766.html
Gli sviluppi più recenti sulla scena internazionale mostrano chiaramente quanto sia difficile far rispettare accordi e norme internazionali. Un caso emblematico è l’ordine esecutivo firmato dal presidente degli Stati Uniti il 24 aprile 2025, che autorizza l’avvio di attività estrattive in acque internazionali (e che andrebbe a vantaggio del gruppo minerario svizzero Glencore), in aperto contrasto con il principio sancito dal diritto internazionale secondo cui l’alto mare rappresenta un bene comune dell’umanità (common good of mankind).
Non si tratta di un caso isolato: nel gennaio 2024 la Norvegia era diventata il primo Paese al mondo ad autorizzare su scala commerciale l’estrazione mineraria nei propri fondali, salvo poi ritirare la legge pochi mesi dopo a seguito di forti pressioni interne.
Lo strano caso della nave danese in Papua Nuova Guinea
A tutto ciò si aggiungono scenari più ambigui, come quello documentato da Willem Marx in un reportage pubblicato nel giugno 2025 dalla rivista Le Scienze. Il giornalista ha seguito l’equipaggio della nave danese Coco, operativa nel mare di Bismarck, nelle acque territoriali della Papua Nuova Guinea, dove estrae masse di sedimenti ricchi di metalli con una benna idraulica da 12 tonnellate. Ufficialmente, per questi test di fattibilità sull’estrazione mineraria nei depositi ricchi di rame e oro dei fondali oceanici, sono state raccolte 200 tonnellate di materiale, ma la stima reale, scrive il giornalista, potrebbe superare le 600. Il tutto è basato su una controversa licenza concessa nel 2011 dall’autorità mineraria locale.
Dopo aver contattato in merito varie autorità dell’isola a sud est del pacifico, Marx ha ottenuto risposta da Julius Chan, già primo ministro della Papua nuova Guinea, il quale gli ha scritto che le persone coinvolte in questo progetto «di certo non hanno il sostegno e l’approvazione del mio governo», e che considerava «illegale la presenza di qualsiasi nave o attività mineraria in quell’area».
Inoltre, scrive il giornalista, si sa ancora troppo poco sugli impatti di campagne di estrazione mineraria come quella portata avanti dalla Coco sulla vita marina e gli ecosistemi dei fondali oceanici. Possiamo però avere un’idea di cosa aspettarci: Marx cita «uno studio su alcuni operatori statali giapponesi che hanno scavato per estrarre solfuri a profondità simili, diverse migliaia di miglia più a nord dell’oceano Pacifico (…). I ricercatori hanno valutato l’impatto sulla flora e sulla fauna del fondale circostante per tre anni dopo un breve periodo di estrazione; hanno rilevato che le popolazioni di organismi grandi meno di 2,5 mm tornavano e livelli normali entro un anno, ma le specie più grandi continuavano essere impoverite più di tre anni dopo. In quel caso l’attività estrattiva era durata appena sei ore».
Anche l’uomo, precisa Willem Marx, potrebbe però subire direttamente delle conseguenze: «da quando nel 2023 uno studio ha scoperto che alcuni noduli polimetallici hanno una tale quantità di radiazioni da poter causare danni alla salute se maneggiati in modo errato, sono aumentati i dubbi su quanto sia saggio estrarli». E forse anche per questo «Diversi paesi, tra cui Germania, Spagna e Cile, hanno chiesto la sospensione, citando i pochi dati scientifici sugli impatti ambientali a lungo termine. Palau e le Figi hanno proposto una moratoria, mentre la Francia vuole direttamente la messa al bando».
Non resta che osservare come evolverà la nuova geopolitica degli abissi, anche alla luce del codice internazionale per l’estrazione mineraria sottomarina, la cui adozione è attesa entro la fine dell’anno. Intanto, però, le attività estrattive nelle profondità oceaniche sono già iniziate, spesso al di fuori dei limiti stabiliti dal diritto internazionale. La nuova segretaria generale dell’Autorità Internazionale dei Fondali Marini, l’oceanografa brasiliana Leticia Carvalho, in carica da gennaio di quest’anno, ha annunciato l’intenzione di interrompere quelle che definisce relazioni eccessivamente strette tra l’ISA e gli operatori industriali. La speranza è che riesca davvero a tracciare una rotta più trasparente e responsabile per il futuro degli oceani.