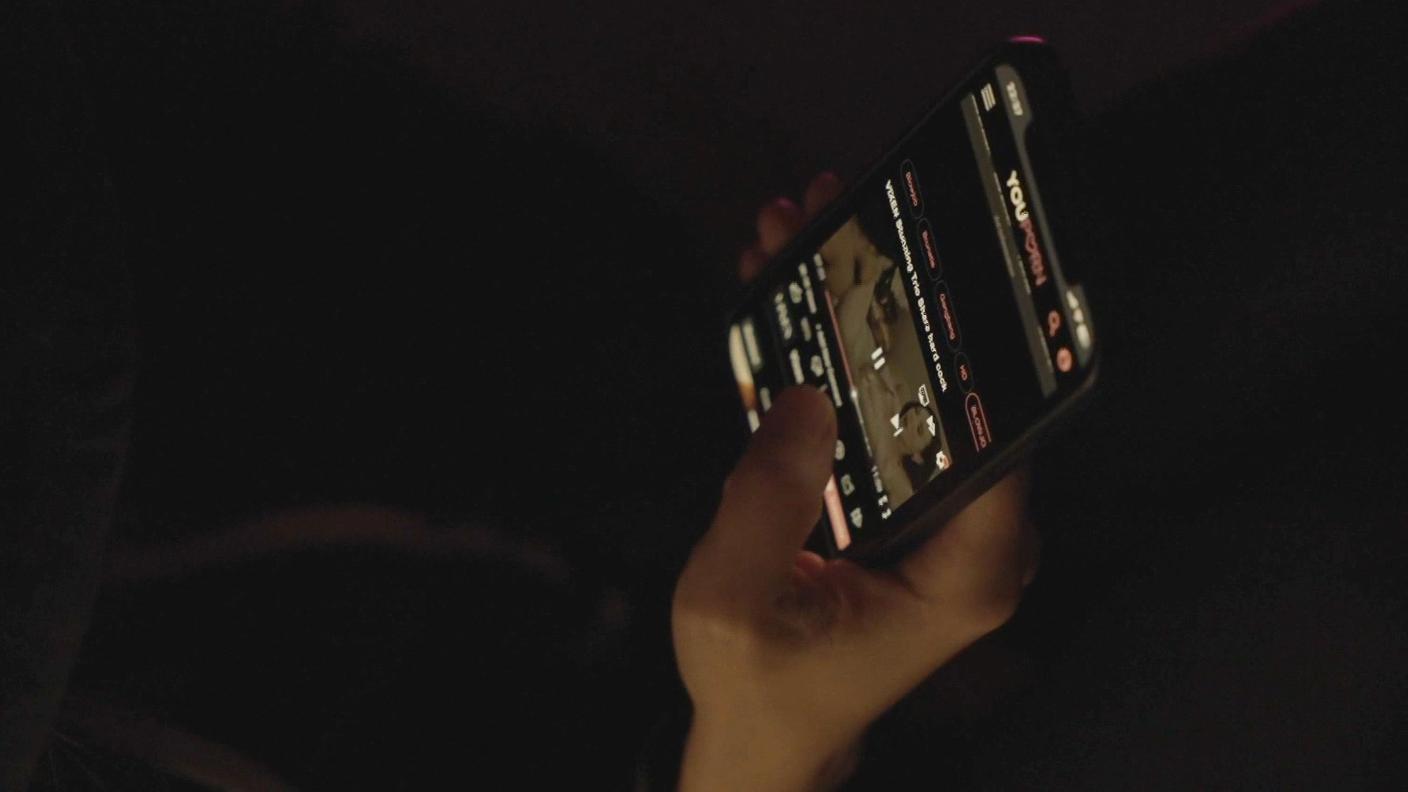I giovani della generazione Z sono svogliati, arroganti e non sono pronti ad affrontare il mondo dei grandi. Sono poco motivati e poco propensi a rimboccarsi le maniche, perché sono facilitati dalla tecnologia.
Queste sono tesi che si sentono nei corridoi delle aziende, forse montate ad arte in uno scontro generazionale che ricalca scontri analoghi nei decenni passati. Come ad esempio quello tra i Baby boomer, i nati tra gli anni ‘50 e ‘60 ed i Millennials (o generazione Y), ovvero la generazione nata tra il 1981 e il 1996.
Ma quali sono i fattori che portano il mondo degli adulti ad avere questa percezione? E soprattutto, è davvero così impietoso il ritratto che la società ha dei giovani d’oggi?
La generazione Z, ovvero i nati tra il 1997 e il 2012, è cresciuta in un contesto di grandi trasformazioni economiche e sociali, nel pieno boom della digitalizzazione. Molti lavori tradizionali scompaiono o perdono appeal e prendono piede nuove modalità di lavoro smart, flessibili e che permettono di bilanciare meglio vita privata e carriera.
E qui nasce lo stereotipo: questa generazione non vuole impegnarsi per raggiungere i propri obiettivi o addirittura di obiettivi neanche ne ha. Ma per loro non è un problema. Perché c’è sempre la vita virtuale, visto che sono sempre più dipendenti da schermi e tecnologie. Quella tecnologia che oltretutto, vale la pena sottolinearlo, ha avuto un’accelerazione incredibile durante il periodo della pandemia da Covid.
https://rsi.cue.rsi.ch/cultura/filosofia-e-religione/25-aprile-perch%C3%A9-ancora-fare-memoria--2776777.html
La dipendenza dal telefonino
“Io credo che ci sia un problema”, afferma Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’Università degli Studi di Milano. “Abbiamo avuto un cambiamento drastico dello stile di vita e del modo di crescere che è avvenuto nell’arco di soli 15-20 anni. Un cambiamento che ha spostato sia il tempo della vita che quello dell’età evolutiva dal mondo reale a quello virtuale. Le ricerche ci dicono che i nostri figli adolescenti trascorrono dalle 3 alle 6 ore al giorno dentro il mondo virtuale. Ci parlano dunque di un cambio di contesto totale. Questi sono ragazzi e ragazze che devono tenere insieme due vite: la vita reale e quella virtuale. Devono tenere insieme due identità: quella che noi vediamo nel reale e quella dei profili social, che potrebbe essere completamente diversa. E c’è una complessità che è difficile da risolvere. Sia per il mondo degli adulti, che del virtuale sa poco o niente perché non è cresciuto in quel territorio, sia per i giovani, perché per la prima volta si trovano a vivere un’esperienza di allenamento alla vita che ha caratteristiche non codificate, che vengono scritte sulla loro pelle”.
“Veramente la tecnologia facilita le nostre vite? La nostra risposta è no - racconta da parte sua il giovane Leo -. In questa fascia generazionale siamo soggetti a più dipendenze. A queste se n’è solo aggiunta un’altra: la dipendenza dalla tecnologia. A causa del virtuale siamo sottoposti ad una visione del mondo dove tutto sembra perfetto, dove la gente tende a mostrare solamente quello che va bene. Questo porta pressioni sociali, ansia da confronto e bassa autostima. Ma ci sono anche anche altre complicazioni, come ad esempio le difficoltà nelle relazioni sociali o nelle relazioni reali al di fuori del mondo virtuale”.
“Se sei ragazzo ed entri tantissimo nel mondo digitale ti accadono due cose”, prosegue Alberto Pellai. “La prima è che vivi costantemente in una sorta di luna park e di paese dei balocchi, dove sei costantemente sollecitato a giocare, chattare e fare scrolling. E sono tutti procedimenti istantanei che il nostro cervello recepisce come incredibilmente piacevoli. Ma sono lontani anni luce da quello che dobbiamo fare dentro alla vita reale”. “Il secondo aspetto - continua - è che nei social vedi vite perfette, gente bellissima, che fa viaggi stupendi e raggiunge traguardi incredibili. L’influencer ha solo tre anni più di te e ha già raggiunto tutto questo. Ma qual è il percorso che ha reso possibile arrivare a questa gigantesca felicità? Non c’è un solo percorso, spesso è un mix di tante combinazioni tra cui c’è anche la fortuna. Nei social hanno un corpo perfetto e hanno intorno gente di grandissima popolarità. Ma tutto questo è lontano dalla vita reale. Perché tutti noi abbiamo corpi imperfetti, vite faticose e facciamo percorsi molto impegnativi per arrivare a traguardi che non sono lì, dietro l’angolo. Ma anzi, vanno conquistati. E quindi i ragazzi sviluppano un’ansia comparativa e performativa che forse non si era mai vista nel mondo dell’adolescenza”. “Poi, per saper essere - dunque per sapere abitare la vita non sentendosi né in balìa, né travolti, né inadeguati - bisogna ritornare dentro la vita reale, cioè la palestra in cui noi ci fortifichiamo con la nostra muscolatura emotiva, cognitiva e socio relazionale non sarà mai un social o uno schermo, ma sarà sempre la vita reale”.
“Il compito degli adulti è proprio quello di accompagnare e supportare la nuova generazione ad avere uno spirito critico sulla tecnologia. Cercare di riconoscere gli effetti positivi e quelli che invece sono dannosi. È importante aiutarli a trovare una giusta misura e a saper mettere dei limiti”, afferma Nadia Holenstein Notari di Pro Juventute.
“Quello che mi preoccupa è l’uso di tutte quelle piattaforme che facilitano la vita, perché manca il manuale d’uso - rende attenti Sara Rossini Monighetti, formatrice professionale. Se pensiamo all’arrivo dell’intelligenza artificiale, noi adulti sappiamo come utilizzarla perché abbiamo avuto un passato, abbiamo un pensiero critico. Il rischio effettivo che io vedo nei giovani adesso è quello della sostituzione: se chiedo a ChatGPT di farmi il compito e poi non lo rileggo e non lo assimilo, non svilupperò le competenze necessarie in seguito nel mondo del lavoro”.
“Ci sono giorni che mi perdo su questi dispositivi. Alla sera poi mi sento veramente vuoto, perché ho buttato tutta la giornata così…”, afferma ancora Leo. “Lo sviluppo naturale della tecnologia ci ha portato a concentrare gran parte dei nostri bisogni sul telefono. Ne siamo dipendenti per la scuola, il lavoro, le relazioni, la vita. È uno strumento del quale è facile essere succubi, ma secondo me non c’è bisogno di proibizionismo. Piuttosto bisogna insegnare ad usarlo”, prosegue Leo.
“Il telefono non è più uno strumento. Purtroppo è diventato un ambiente di vita. Ci entri, il tempo trascorre e non ti accorgi che sono passate 2 o 3 ore. Se invece hai in mano la calcolatrice, che è uno strumento, fai i calcoli che ti servono poi la spegni, non te la porti a letto. Noi invece ci svegliamo all’una di notte e guardiamo il telefonino perché non è uno strumento… è diventato la vita parallela. Cioè un luogo in cui fare tutto quello che si fa nel reale ma in un altro modo, spesso più divertente e gratificante”, chiude Alberto Pellai.
Le difficoltà nel modo del lavoro
Quando i giovani arrivano nel mondo del lavoro c’è una rottura. Ma dove c’è la rottura? Che cosa le aziende non capiscono dei giovani di oggi? E perché i giovani che oggi entrano nel mondo del lavoro non riescono a trovare un compromesso rispetto a quanto viene loro richiesto? Dove nasce questa scollatura?
“Il datore di lavoro si aspetta che i ragazzi siano già pronti e che abbiamo le sue stesse aspettative, quindi un posto fisso ed una carriera. Dall’altra parte abbiamo invece una generazione: per loro invece non è una corsa al titolo di prestigio. È più una corsa ad esprimere il proprio potenziale ed essere accettati per quello che si è. E qui sta lo scollamento”, spiega Sara Rossini Monighetti, formatrice professionale.
“In passato c’era la necessità del posto fisso. Oggi, con le tecnologie e il cambiamento continuo delle aspettative, i ragazzi della nostra età hanno la necessità di realizzarsi a livello personale. Quindi non necessariamente andare a lavorare per un’azienda”, spiega la giovane Lucrezia.
“Sono d’accordo. Mi scontro spesso con i genitori che vorrebbero far fare un percorso stabilito ai loro figli, perché porta ad un contratto di lavoro e a uno stipendio che risolve tutti i problemi. Sono tutti focalizzati su questo aspetto”, conferma Sara Rossini Monighetti.
“Quello che divide sono le priorità tra noi e gli adulti”, spiega ancora Leo. “Abbiamo problemi diversi da quelli delle generazioni passate, per esempio il cambiamento climatico. E abbiamo visto il mondo del lavoro, ma tanti non sono disposti a farne parte, perché non ne condividono diversi aspetti”.
“Questa è una generazione che non cerca i valori solo sulla carta: l’azienda certi valori deve proprio dimostrarli”, aggiunge Sara Rossini Monighetti. “Se dico che nella mia azienda la crescita del personale è prioritaria, il giovane poi il corso per la crescita lo vuole vedere”.
Ed infine c’è la questione della gerarchia. “Questi giovani cercano realtà poco gerarchiche. Gli adulti la leggono come arroganza. Ma lo fanno perché hanno paura del confronto. E succede perché questa generazione, se ti deve dire qualcosa, lo fa. Questa generazione non accetta la frase “fa questa cosa qui perché te lo dico io”. Il giovane ti guarda e ti risponde: “Ma perché devo farla? Spiegami”. Ma non è arroganzam è che vogliono capire il senso. Da qui lo scontro generazionale: questi giovani non sono degli esecutori, sono persone che vogliono dare un valore a quello che stanno facendo”.
“L’importante è il legame di fiducia”, conclude Nadia Holenstein Notari. “Quando noi adulti chiediamo qualcosa ai giovani, dobbiamo essere noi il primo loro esempio positivo. Senza questo non avranno fiducia in noi e non riusciranno a fare il loro percorso per entrare nella nel mondo del lavoro e nella società”.