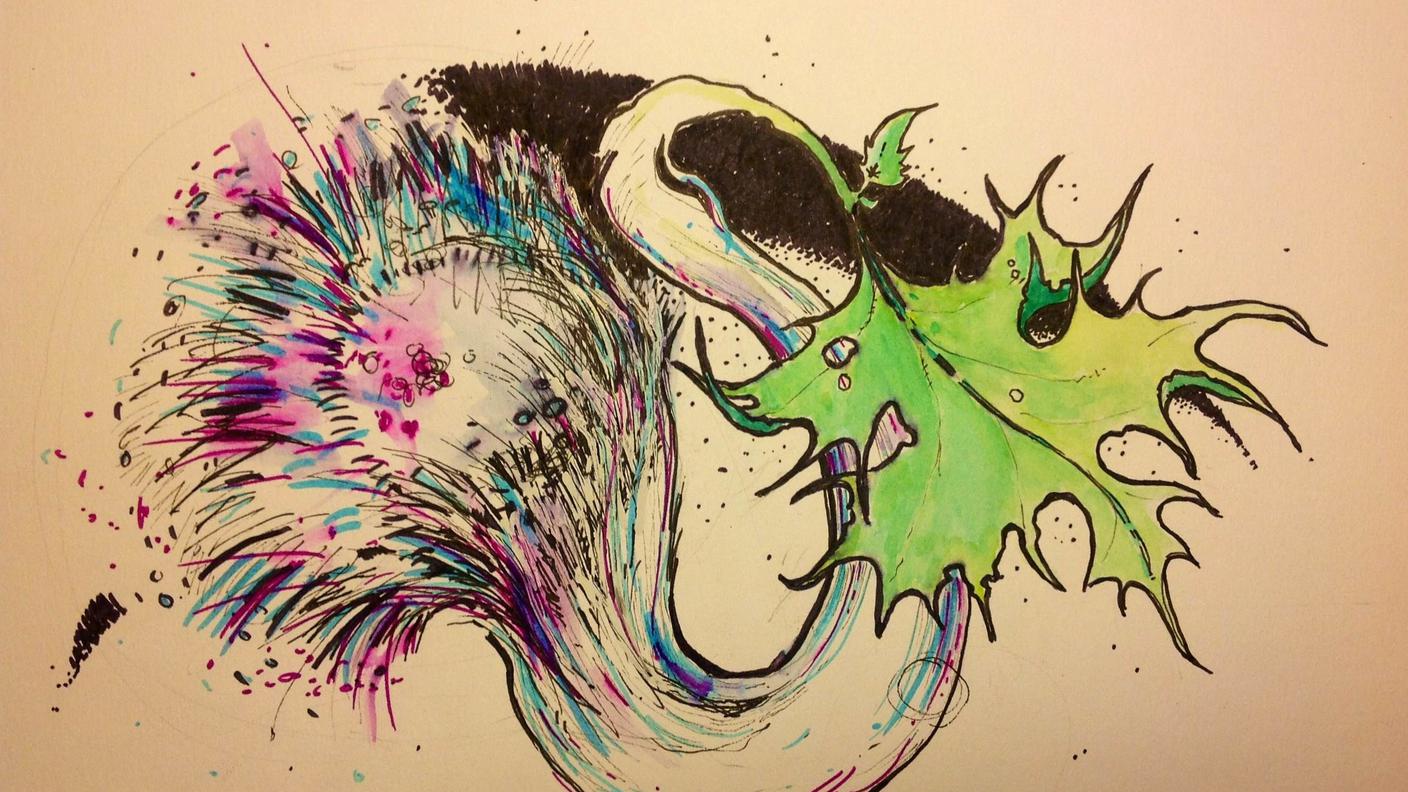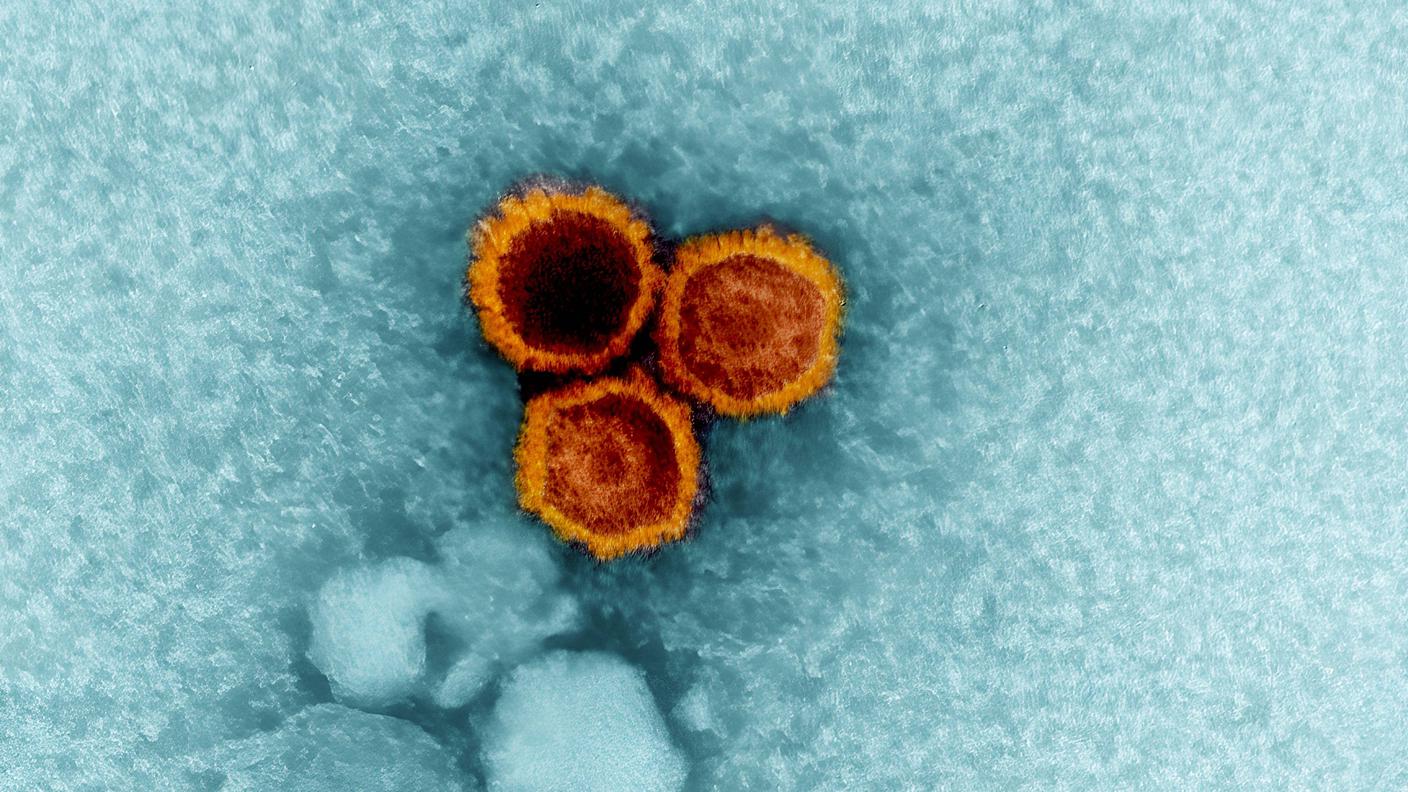Guardando le fotografie di tramonti o fiori dallo schermo del cellulare, c’è spesso la sensazione che i colori siano più belli che dal vivo. Intensità, contrasto e profondità sono in qualche modo migliori rispetto a quanto vediamo nel mondo reale. Le superfici brillanti sembrano più luminose, mentre i colori flebili paiono prendere energia per diventare vibranti, ipnotici.
Questo magnifico effetto è il risultato di delicati accorgimenti nello sviluppo delle tecnologie da parte dei produttori. Gli sforzi si concentrano sia verso le fotocamere, che catturano l’immagine, ma anche – e forse soprattutto - verso gli schermi, che la riproducono. Le fotografie sono così rappresentate in modo estremamente dettagliato e vivo, soprattutto se le paragonate ai telefonini dagli schermi decisamente sgranati di quindici anni fa.
Pillole di colore
La serie “pillole di colore” della redazione digitale del giardino di Albert cerca di rispondere alle domande più insolite e curiose legate al colore nella nostra quotidianità: a che serve il colore in natura? I colori possono davvero influenzare la nostra mente? E com’è riuscito Homo sapiens a produrli nelle varie epoche? Scopri il contributo video legato a quest’articolo dalla pagina Facebook di RSI Cultura!
La ricerca sulle tecnologie degli schermi, che trovano sempre più applicazioni nel mercato, non si arresta ed è sempre più interdisciplinare. Fisici e chimici lavorano fianco a fianco per sviluppare i concetti base, gli ingegneri elettronici si sforzano per assemblare oggetti robusti e affidabili, gli informatici fanno dialogare gli schermi con il resto del dispositivo. Immagini di qualità che oggi, tra smartphone, touch screen e cartelloni pubblicitari dominano la nostra società. Difficile, infatti, far trascorrere una giornata senza servirsi di almeno uno di questi dispositivi, che sia all’interno dell’auto o sulla scrivania dell’ufficio.
Il tubo catodico
Ai più “âgé” suonerà strano, ma oggi ci sono moltissime persone, soprattutto in età scolastica, che non hanno mai visto un film su un televisore col tubo catodico. Per chi se le è già scordate, sono quelle apparecchiature piuttosto voluminose che fino a una ventina di anni fa costituivano lo standard degli schermi di casa. Queste funzionano con un vero e proprio acceleratore di elettroni che spara le particelle contro lo schermo coperto da uno strato di materiale fosforescente, detto brevemente “fosfori”, che si attiva ed emette luce. Delle bobine regolano la direzione del fascio e, mandandolo da un punto all’altro, permettono all’immagine di formarsi e aggiornarsi continuamente, dando la sensazione di movimento degli oggetti. All’inizio, però, il televisore a tubo catodico era solo in bianco e nero.

Che il colore sia!
RSI Archivi 01.10.1968, 15:24
Negli anni Quaranta e Cinquanta vengono sviluppati dei televisori in grado di separare il segnale corrispondente al colore rosso da quello blu e quello verde. In questo modo, è possibile regolare i tre colori primari e generare idealmente tutte le sfumature di colori che conosciamo. In Svizzera, la televisione a colori è arrivata il primo ottobre 1968.
Gli schermi piatti
La rivoluzione, avvenuta a rapidi ma graduali passi, è cominciata quando gli schermi hanno contemporaneamente aumentato la qualità dell’immagine e ridotto il volume dell’apparecchio. I primi televisori di questo tipo, diffusi verso la fine degli anni Novanta, sono stati quelli al plasma. In questa tecnologia, lo schermo è composto da tante piccole cellette contenenti un misto di neon e xeno sotto forma di gas. Attraverso l’elettricità, che porta il segnale video, i gas vengono trasformati in plasma, lo stato della materia né liquido né gassoso che compone anche i fulmini. Il plasma può quindi attivare il fosforo sul vetro, similmente a quanto avviene per i tubi catodici.
Questa tecnologia è stata rapidamente rimpiazzata dagli schermi a cristalli liquidi, gli LCD, dove una particolare proprietà della luce detta “polarizzazione” viene sfruttata per generare l’immagine.
Ben presto, per televisori, telefonini e laptop, la tecnologia a cristalli ha lasciato spazio agli schermi OLED, che oggi dominano il mercato. L’acronimo che sta per organic light emitting diode (diodo organico a emissione di luce), dove “organico” intende a base di carbonio e non, come si è erroneamente tratti a pensare, di origine biologica. Oggi non solo i televisori e i monitor dei computer sono OLED, ma anche la maggioranza degli smartphone.
Alla base degli schermi OLED c’è un meccanismo molto sofisticato dove la corrente elettrica passa da un materiale a carica positiva a uno a carica negativa, emettendo luce. I due materiali sono a base di carbonio e, oltre ad offrire prestazioni eccellenti, hanno il vantaggio di poter essere prodotti in grande numero all’interno di una griglia fittissima su sottili fogli trasparenti, quelli che alla fine compongono i nostri schermi. La tecnologia è raffinata con ulteriori numerosi strati per migliorare robustezza e qualità, ma si basa sempre sul medesimo principio messo a fuoco da Albert Einstein nel 1905. Cioè che a ogni colore della luce corrisponde una quantità precisa di energia: il rosso è meno energetico del verde, a sua volta meno energetico del blu. Quindi, ogni processo elettrochimico che avviene in ciascuno dei pixel degli schermi OLED regola il proprio colore in base all’energia liberata.
Questo non è un gatto
RSI Info 12.07.2021, 20:34
La tecnologia OLED, in fondo, è un tipo particolare di LED, light emitting diode (diodi a emissione di luce). I LED in generale trovano numerosissime applicazioni, come nei telecomandi o nei fari delle automobili, e sono stati a lungo rivali della tecnologia LCD. Oggi, nel mondo degli schermi la vediamo utilizzata soprattutto per le grosse installazioni di concerti, stadi e i cartelloni pubblicitari. In questo caso, tre LED monocromatici dei colori base, rosso, verde e blu, sono messi uno accanto all’altro molto vicini e formano così un pixel, l’unità che compone uno schermo. In base all’intensità con cui si accende ciascuno di essi si regola il colore emesso. Ad esempio, nel caso in cui i tre siano accesi alla medesima potenza, si ottiene la luce bianca.
La scoperta dei LED blu
I tre vincitori del Nobel per la fisica 2014 (da sinistra) Isamu Akasaki, Hiroshi Amano e Shuji Nakamura alla cerimonia di premiazione a Stoccolma.
Forse non tutti sanno che, mentre i LED rossi e verdi sono stati scoperti negli anni Sessanta e Settanta, per quelli blu si sono dovuti aspettare oltre vent’anni. Il meccanismo di base prevede l’emissione di luce in seguito al passaggio di corrente da un materiale caricato positivamente a uno caricato negativamente. In base alla natura dei due materiali viene determinato il colore della luce, ma per decenni i ricercatori non sono riusciti a trovare la combinazione giusta per la luce blu. Nel 1991, tre scienziati giapponesi Isamu Akasaki, Hiroshi Amano and Shuji Nakamura, hanno finalmente annunciato di aver raggiunto l’ambito traguardo, dando il via alla possibilità di realizzare tutti i colori della luce con la tecnologia LED attraverso, appunto, la combinazione con quelli rossi e verdi. La portata della scoperta fu tale che nel 2014 i tre ricercatori ricevettero il premio Nobel per la fisica. Oggi, è grazie a questo diffusissimo gioiello tecnologico che le nostre città e le nostre case sono arricchite da luce bianca ad alta luminosità e basso consumo energetico.
Immagine e suono
Dando una sbirciata al futuro, le nuove trovate in materia di schermi e colori non sembrano più andare nella direzione della risoluzione, una parola simbolo dei progressi tecnologici dei primi anni Duemila, e né della gamma cromatica. Una delle più recenti innovazioni, infatti, prevede la capacità degli schermi OLED di emettere suoni direttamente dai pixel. Ci vorrà del tempo prima che la scoperta, pubblicata a maggio su Advanced Science da un team dell’Università di scienze e tecnologia Pohang (POSTECH), in Korea del Sud, trovi posto nei processi produttivi a fini commerciali. Per fare un esempio pratico, grazie a questa nuovissima tecnologia non si sentirà più la voce dei personaggi dei film uscire dalle casse poste accanto al televisore, ma dalla precisa posizione della bocca dell’attore, come accade nel mondo reale.
Contrariamente ai tentativi di scarso successo da parte di varie aziende, la squadra di POSTECH non ha semplicemente posizionato dei diffusori acustici dietro lo schermo, ma ha permesso ai pixel stessi di emettere suono attraverso un cosiddetto elemento piezoelettrico. Tralasciando i dettagli tecnici che si nascondono dietro questo termine, il sistema permette agli schermi di emettere suoni di alta qualità e restare sottili come quelli attuali, caratteristica essenziale per le applicazioni che devono affrontare al giorno d’oggi.
La direzione che gli schermi sembrano prendere è quella di un’esperienza sempre più immersiva, coinvolgente e multisensoriale. Mentre ci sono diversi tentativi di includere il tatto, ad esempio cercando di restituire la sensazione di scrivere su carta, ci resta spazio per sognare uno schermo fantascientifico che possa generare anche gusto e olfatto.