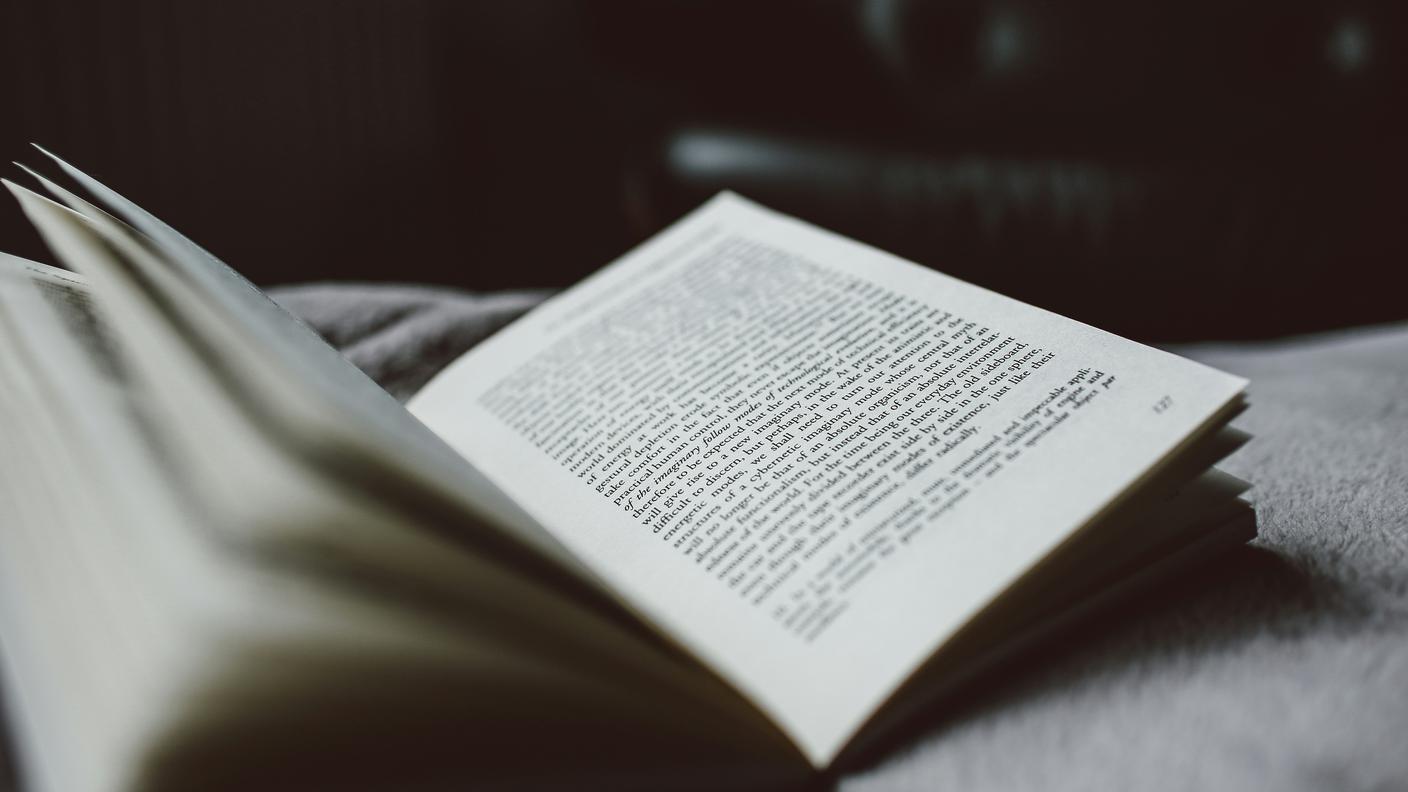L’educazione musicale di una gran parte dei millenial è passata da Pitchfork, il magazine musicale online che è stato definito dall’Atlantic come “la più importante pubblicazione culturale del 21° secolo”. Ma è notizia di qualche tempo fa che Pitchfork verrà praticamente smantellato. Purtroppo, questo fatto non deve stupirci.
Pitchfork era nato come blog nel 1996 (!) ed era poi diventato celebre grazie a due caratteristiche: le recensioni provocatorie e un po’ cervellotiche scritte da redattori estremamente preparati e la sua capacità di scoprire e portare alla notorietà artisti eccezionali ancora sconosciuti. Wilco, Arcade Fire, Bon Iver, Death Cab for Cutie e Modest Mouse, oggi considerati pilastri della scena indie, erano pressoché ignoti al grande pubblico prima di apparire sulle pagine virtuali di Pitchfork.
Così, nei primi anni Duemila, il magazine era diventato un punto di riferimento imprescindibile per chi era alla ricerca di musica diversa, lontana dalla luce dei riflettori, che veniva invece trattata da Rolling Stone, il grande rivale di Pitchfork. La notorietà e un pubblico di lettori assidui aveva permesso ai redattori della testata di professionalizzarsi.
Nel 2015 era stato acquistato da Condé Nast, il colosso editoriale capitanato da Anna Wintour che conta, tra i suoi brand, magazine celebri come Vogue, The New Yorker, Vanity Fair e Wired. A gennaio di quest’anno, però, Condé Nast ha deciso di licenziare buona parte della redazione e di spostare ciò che rimane (quindi probabilmente ben poco) all’interno di GQ, il magazine dedicato al mondo maschile. La domanda, quindi, sorge spontanea: perché sta succedendo tutto questo?
La prima ragione, come spesso accade, è economica. Oggi tutte le pubblicazioni digitali gratuite e supportate dalla pubblicità – come Pitchfork – faticano a sopravvivere e molte di esse sono anzi costrette a chiudere. Il fenomeno non è ovviamente limitato al mondo musicale: sono finite così anche testate qualitativamente valide e di grande successo come Buzzfeed News, Protocol, Gawker e Vice. Quest’ultima contava, all’interno del suo portfolio, anche Noisey, un magazine dedicato proprio alla musica indipendente.
Il modello delle inserzioni online, infatti, è in crisi. Ora i siti web hanno un’entrata monetaria quando un utente, spesso partendo da una ricerca su Google o da un post sui social media, clicca un link e arriva sulle loro pagine e visualizza inserzioni pubblicitarie. Visto il basso costo delle inserzioni, il sistema funziona solo in presenza di un traffico di utenti considerevole. Ma, negli ultimi anni, sia Google sia i social mandano sempre meno traffico sui siti, e quindi le entrate ultimamente sono crollate. Chartbeat, un servizio di web analytics, ha riportato che, un anno fa, le testate giornalistiche online ricevevano il 50% del loro traffico dai social di Meta (Instagram e Facebook); a gennaio di quest’anno, invece, la percentuale era scesa al 33%. Alcune testate, poi, sono state colpite più di altre: Mother Jones, rivista politica progressista statunitense, ha riportato un calo del 99% rispetto a qualche anno fa.
E il futuro sembra riservare ulteriori cattive notizie. Le intelligenze artificiali, che stanno prendendo sempre più piede anche nel campo delle ricerche online, forniscono contenuti agli utenti direttamente all’interno dei propri servizi. Sarà quindi sempre più normale chiedere a Google, a ChatGPT o a Copilot quali sono gli album indie folk più belli del 2024 e ricevere la risposta senza dover aprire nessun link – cioè senza visualizzare le inserzioni dei siti, che quindi si ritroveranno sempre più privati anche di queste entrate.
La seconda ragione dietro alla crisi delle testate come Pitchfork è il cambiamento del mondo della musica stessa. Fino all’avvento dell’era dello streaming, i siti musicali servivano a scoprire nuovi artisti e a capire quali CD acquistare: era l’unico modo di ascoltare musica. Persino durante il periodo della pirateria, leggere una recensione poteva avere ancora un senso: bisognava capire se valesse la pena aspettare ore un download da Emule o da Limewire. Ma l’arrivo di Spotify e delle altre piattaforme di musica in streaming ha cambiato le cose: ascoltare un album non richiede più di prendere una decisione importante. Se tutto è disponibile subito e senza costi aggiuntivi, informarsi preventivamente non è strettamente necessario. La musica non viene solo fruita tramite streaming, ma anche scoperta: gli algoritmi di intelligenza artificiale conoscono i nostri gusti, a differenza di qualsiasi (pur preparatissimo) recensore di Pitchfork, e quello che ci propongono coglie spesso nel segno.
Ma la grande forza dei magazine musicali non è la valutazione qualitativa dei singoli album, né la capacità di far scoprire nuove cose. È la capacità di contestualizzare quelle cose. E proprio in questo periodo storico, in cui vengono pubblicati più di 120mila brani al giorno, è paradossale che realtà come Pitchfork siano in crisi; perché, specialmente ora, abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti a orientarci e capire un po’ meglio quello che sta succedendo.
Giornalismo musicale al collasso?
Voi che sapete... 25.01.2024, 10:00
Contenuto audio