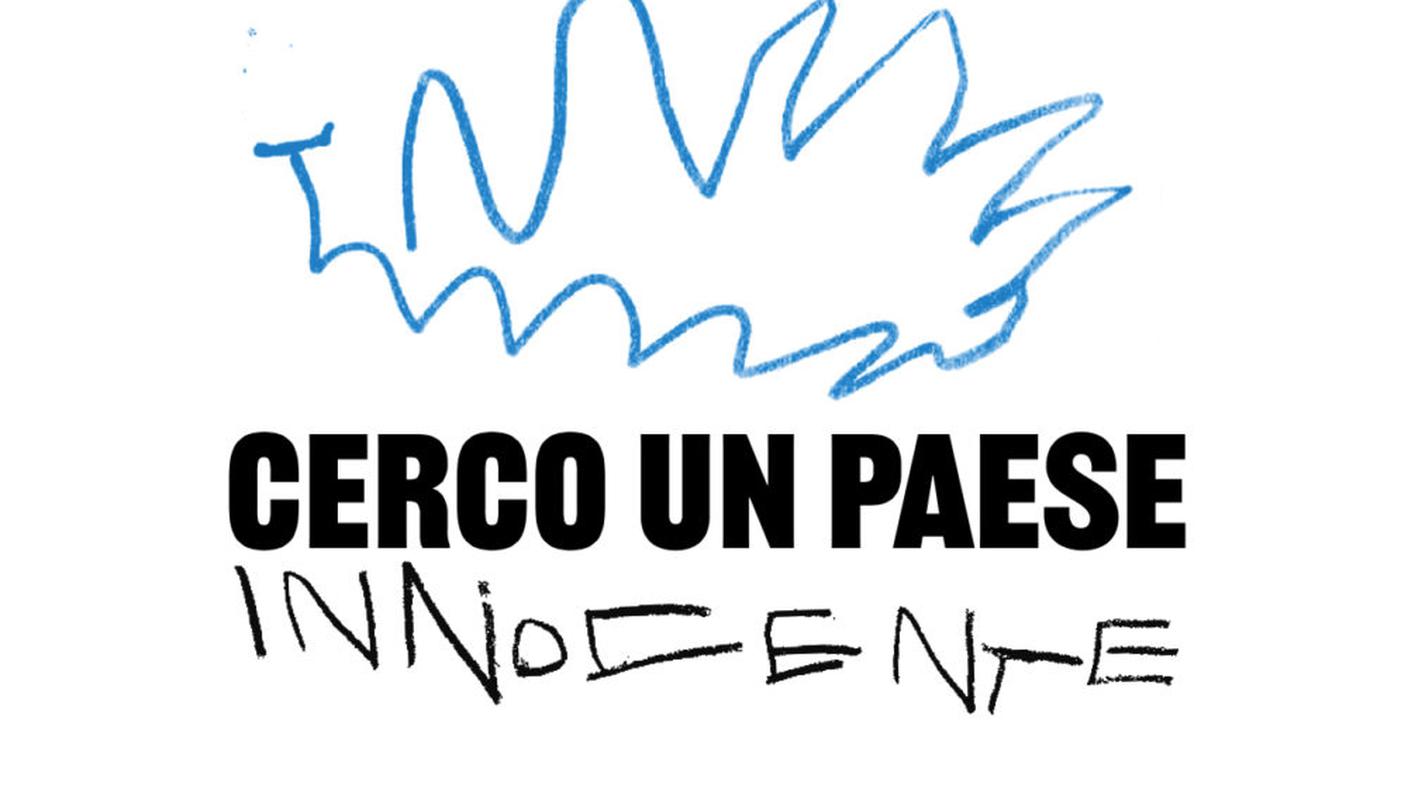Ci sono romanzieri che riconoscono il proprio specifico nel viaggio: da Omero a Yehoshua, definiscono una sorta di epica della migrazione. Altri, come Benet, come Beckett, sono scrittori dell’immobilità. Tra questi due poli, magistralmente, si muove Miloš Crnianski (26 ottobre 1893 - 30 novembre 1977), lo scrittore russo del capolavoro Migrazioni. Un romanzo che riesce altrettanto esemplare quando indaga le minuzie, le grandiose minuzie, del sentimento e del desiderio più intimi e quando indugia su quell’estrema condizione del corpo e dello spirito che è la migrazione, il viaggio senza fine, in tempo di guerra.
Due poli inconciliabili, addirittura incompatibili? Piuttosto, diremmo, due poli che si richiamano e riflettono a vicenda, essendo la natura dell’umano – questo sembra suggerire l’oceanico romanzo di Crnianski – nella perpetua ricerca del movimento e dell’immobilità. Ma non perché il movimento cerchi l’immobilità o viceversa, bensì perché la natura dell’uomo sembra ritrovarsi e perdersi a un tempo nell’uno come nell’altra.
Romanzo di passione e di guerra, Migrazioni è in effetti questo riecheggiare di due mondi, di due condizioni dello spirito, l’una sull’altra: da una parte la vicenda del condottiero Vuk Isakovič, guerriero di lunga data e comandante del reggimento Slavonia-Danubio, composto di commilitori serbi, che intraprende le campagne di conquista sotto le direttive dell’impero austro-ungarico della leggendaria Maria Teresa; dall’altra il fratello dello stesso che, rimasto chiuso nella sedentarietà e nella pace, ne concupisce la moglie, affidata alle sue cure ma vittima infine delle sue trame.
La duplicità, diremmo addirittura la contrapposizione, tra queste due dimensioni sembrerebbe suggerire che qualsiasi scelta intrapresa, sia essa quella l’eroismo bellico o, al contrario, della rinuncia alle armi, non possa condurre che alla nostalgia e al senso dell’assurdo, il quale si esplica tanto nell’agire la propria vita su un campo di battaglia quanto nel riportarla alle amenità della quiete e dalla sedentarietà. In verità, tuttavia, il discorso e il pensiero di Crnianski sono più complessi: ci esortano a comprendere che ogni scelta, ogni destino, ogni deliberazione portano con sé un sentimento di scacco, di disfatta e persino di sconfitta, di tracimazione dell’entusiasmo nella noia e nel senso della caducità.
Vuk e il fratello Arandjel possono infatti sicuramente dimenticarsi, con l’ennesima chiamata alle armi, l’uno dell’altro. E Arandjel avvertire il cupo privilegio della propria vicinanza alla cognata come una tentazione di tradimento, di doppio tradimento, quasi irresistibile. Ma in realtà né l’uno né l’altro finiscono per ritrovarsi se non nel senso dell’assurdo e della capitolazione: il primo perché, riprendendo un titolo di Jorge Amado, stanco di guerra, il secondo perché, al cospetto delle spietatezze del tempo e della vecchiaia, deluso dalla sua stessa voluttà.
È dunque l’assurdo, la noia, la ripetitività, il ricorrere dell’identico, a definire la cifra di questo romanzo. Quasi a ricordarci che qualsiasi scelta si compia nel corso della propria esistenza, sia essa nell’egoismo del desiderio o nell’altruismo della dedizione ai doveri bellici e della fedeltà all’Impero, è destinata, in una forma o nell’altra, alla capitolazione.
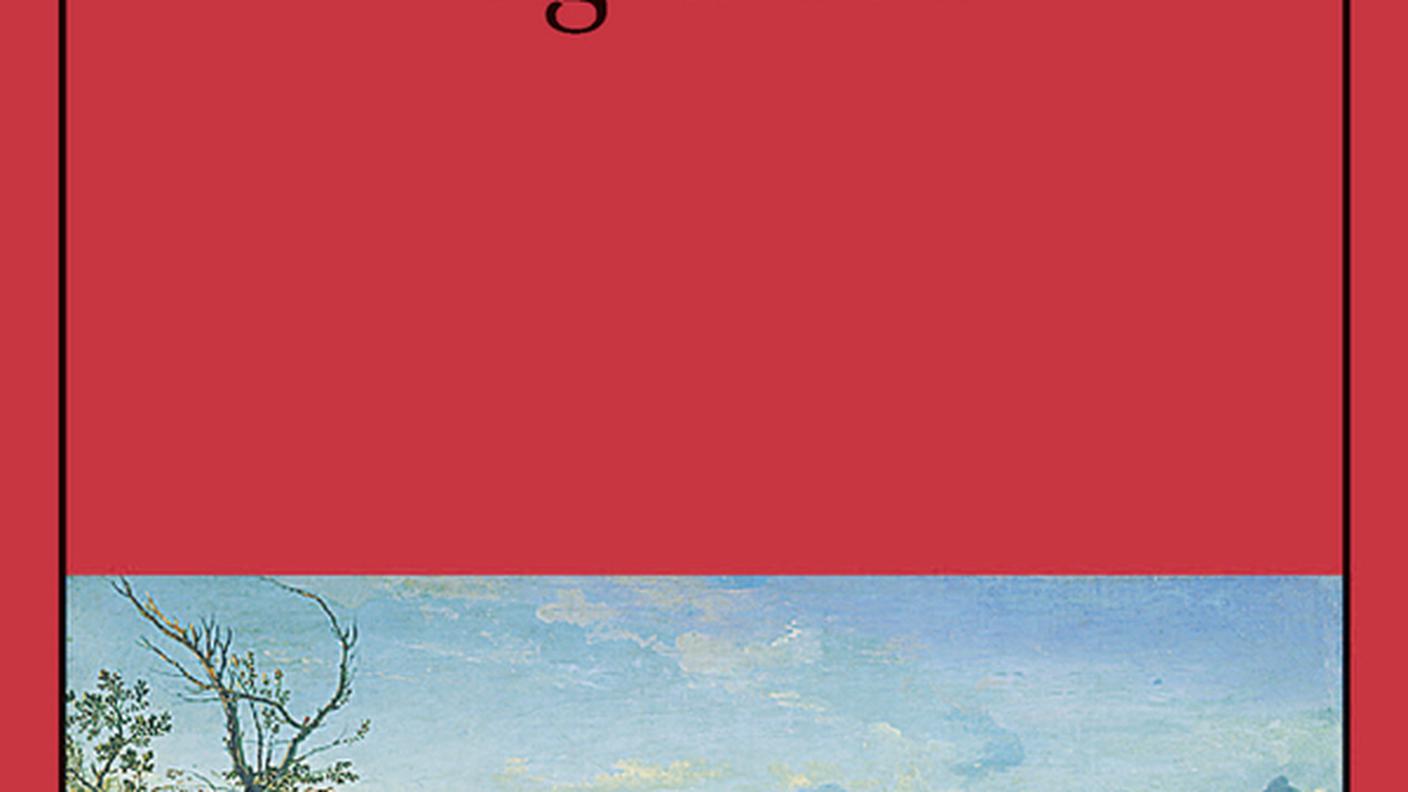
Per cui Migrazioni, oltre che un romanzo di guerra e passione, è prima di tutto un romanzo sul disincanto e del disincanto. Si offre agli imperativi del tempo, della Storia, del destino del proprio popolo, ma alla fine riconosce in sé, quasi nichilisticamente, che la vita è destinata a ricomporsi ogni volta da capo come una sorta di eterna capitolazione, di incessante ritorno alle sue inensatezze essenziali. Perché combattere? Perché amare? Perché mostrarsi fedeli? O perché, al contrario, cedere alle lusinghe dell’infedeltà? Ogni scelta finisce per equivalersi, essendo il desiderio corporale non meno assurdo, e infine non meno insignificante, del desiderio di conquistare un nuovo brano di terra o giungere qualche chilometro più in là sulla strada della vittoria.
Per cui appassionarsi, desiderare, cercare un nuovo orizzonte di felicità e vittoria, non sono che un eterno ritorno dell’illusione tra le terre altre della banalità. Occasioni per sentirsi vivi e coinvolti in un destino, ma in ultima analisi abbagli non meno devastanti della persuasione che la guerra abbia un senso, l’amore uno scopo e la passione un approdo.
Non si arriva mai se non alla nostalgia di potersi dire una volta per tutte arrivati, risolti, ma sempre con l’intima consapevolezza che l’esistenza è programmata per precipitarci nell’assurdo, sia quando si affronta un nemico, marciando da una terra e da una nazione all’altra in cerca di un nuovo fronte, sia quando si precipita nell’ansia di felicità al cospetto di una donna che non ci appartiene.
Migrazioni, una tragica metafora dell’inutilità e dell’assurdità di ogni erranza, è dunque un romanzo della sconfitta e della fatalità. Elegante, delicato, quasi classico nella sua prosa puntigliosa e senza sbavature, indefettibile sul piano della resa dei sentimenti, è in primo luogo un romanzo della rassegnazione. Quasi che Crnjanski avesse voluto dirci: si può cercare il proprio destino e la propria realizzazione ovunque, ma ogni luogo è una sconfitta e ogni orizzonte una resa.