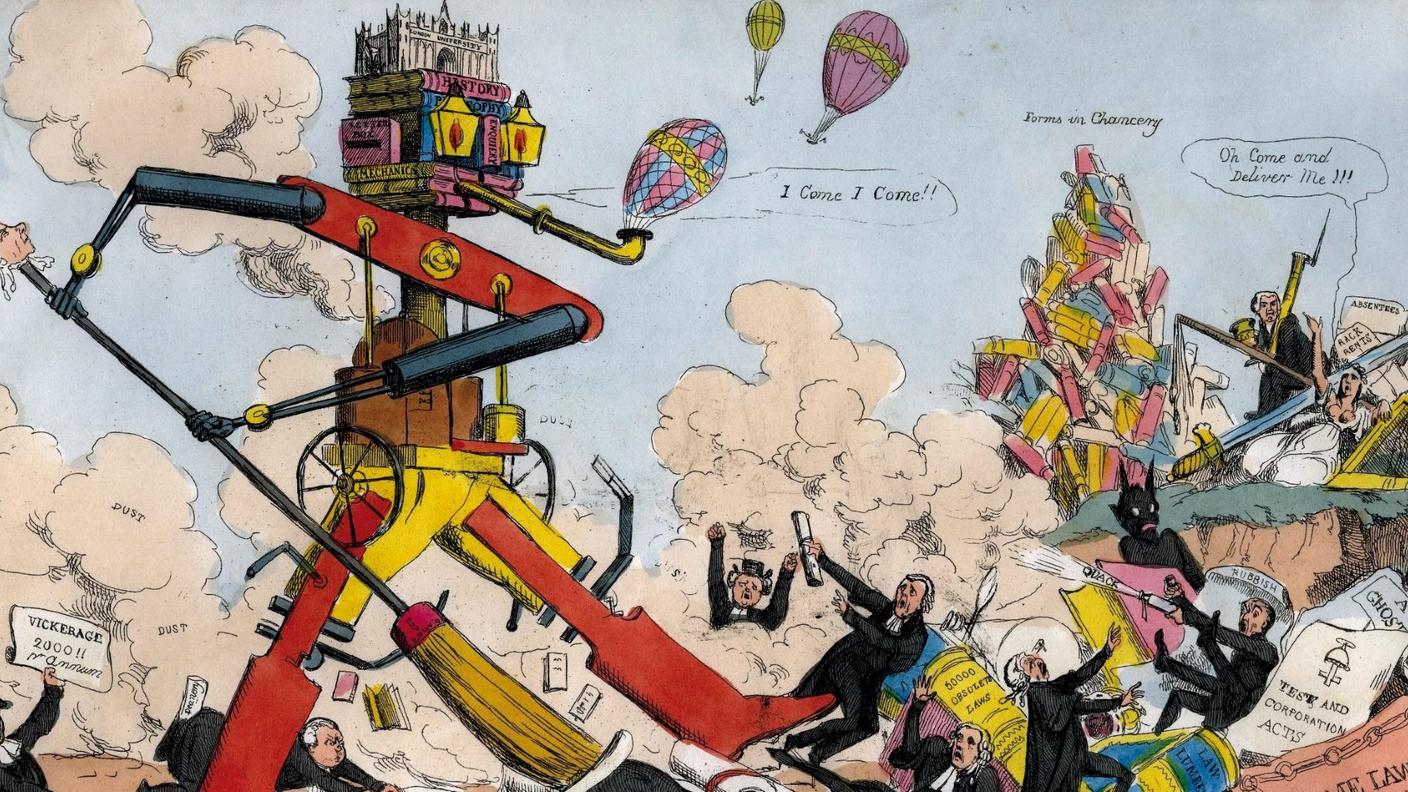Non sono uno storico né, tanto meno, uno storico del fascismo e non spetta certo a me rispondere, col dovuto rigore, alla domanda che, oggi, torna sulla bocca di tanti: Chi è fascista? (questo l'ultimo titolo di Emilio Gentile, massima autorità in Italia sull'argomento). Ma, pur non essendo uno storico, guardandomi attorno, da cittadino che ancora crede che la cultura – in qualunque sua forma – debba essere una testa d'ariete capace di sfondare portoni, non posso non interrogarmi sull'argomento.
L'interrogativo, subito, mi riporta alla mente la conturbante visione di un film che, diciassettenne, lasciò in me un segno indelebile. Allora crescevo a "pane e Pasolini" e, non sapendo bene cosa stessi per fare, misi nel videoregistratore la VHS di Salò o Le 120 giornate di Sodoma. Resistetti pochi minuti (credo, davvero, di non essere arrivato nemmeno alla fine del primo "girone"). Dovetti spegnere il televisore e, come per dare luogo a qualcosa che montava in me con la forza del vomito, prendere il mio quaderno per scrivere su quanto avevo visto. Non ricordo cosa buttai giù con foga. Rammento però perfettamente che non erano state le esplicite violenze a sconvolgermi, ma altro a cui, allora, non davo nome.
I quattro protagonisti della pellicola – il Duca, il Monsignore, l'Eccellenza e il Presidente – in cui, in modo assolutamente geniale, Pasolini ambientava la celebre opera del Marchese De Sade nella Repubblica di Salò, emanavano una malvagità inumana e, per questo, a me completamente sconosciuta. Eppure quanti "cattivi" avevo visto nell'allora mia breve storia di spettatore? Moltissimi. Quell'inumanità era, credo, nella sua forma perfetta, la quintessenza del fascismo.
Pasolini lo aveva spiegato chiaramente in una nota intervista in cui asseriva che non erano tanto il sesso e il sadomasochismo in sé a interessarlo ma, piuttosto, cosa, attraverso di essi, il potere faceva dei corpi (e, di conseguenza, delle anime) delle proprie vittime: vale a dire la loro mercificazione, la loro mutazione in "cose" al servizio di un godimento sfrenato, senza fondo e cieco. Questa acutissima considerazione chiarifica anche perché egli affermasse, attraverso De Sade (il poeta – per dirla con Bataille – dell'uomo sovrano), che il fascismo più puro, più radicale sarebbe stato quello della società dei consumi.
Di fatto, i gerarchi del Salò sono dei divoratori, dei consumatori che, come macabri Mida, trasformano in oggetto della propria pulsione qualunque cosa tocchino. E questa peculiarità è, credo, già presente nella forma incompiuta, e paradossalmente perfetta, del romanzo del Marchese; il libro, come molti sapranno, nella parte finale è perlopiù composto da liste di torture schematicamente descritte e meticolosamente ordinate e redatte (Sade non aveva sviluppato l'opera fino in fondo). Questa forma quasi burocratica della descrizione del delitto – non va dimenticata l'ossessione del romanziere per i numeri – è quanto di più prossimo si può immaginare alla capacità che ha il dominio di annullare l'essere in quanto persona o vivente riducendolo a numero.
Quindi, tornando alla domanda che apriva il discorso, chi è fascista? Al di là del fascismo storico che, sempre secondo Pasolini, probabilmente, in quella precisa forma «non si ripeterà mai più», è fascista chi trasforma la vita e la sua espressione in bieca merce.
Allora c'è forse qualcosa di velatamente fascista in noi, se, consapevoli, consegniamo la nostra intimità a un social network gestito da un miliardario fingendo di non sapere che quelle immagini, che sono depositarie di una memoria privata, andranno ad impinguare la macchina dell'economia vorace. C'è qualcosa di fascista in noi quando compriamo compulsivamente online ignorando che qualcuno, per garantire l'efficienza del servizio (l'efficienza è il marchio della dittatura), lavora in condizioni inumane. Siamo fascisti se, mentre ci bagnamo in un mare assolato, ignoriamo i perseguitati in fuga e i morti alla deriva invece di lanciare, come avrebbe detto Fabrizio De André, «un grido di vibrante protesta».
Non sono uno storico, né, tanto meno, uno storico del fascismo e queste considerazioni potranno forse apparire estreme. Ma se devo, come credo sia giusto, dare voce a una domanda attraverso la cultura che mi ha formato, non posso farlo che in questo modo: le lezioni del prigioniero della Bastiglia e della vittima dell'Idroscalo di Ostia suggeriscono che è in una precisa forma di alienazione dalla vita che si fa tana il fascismo.