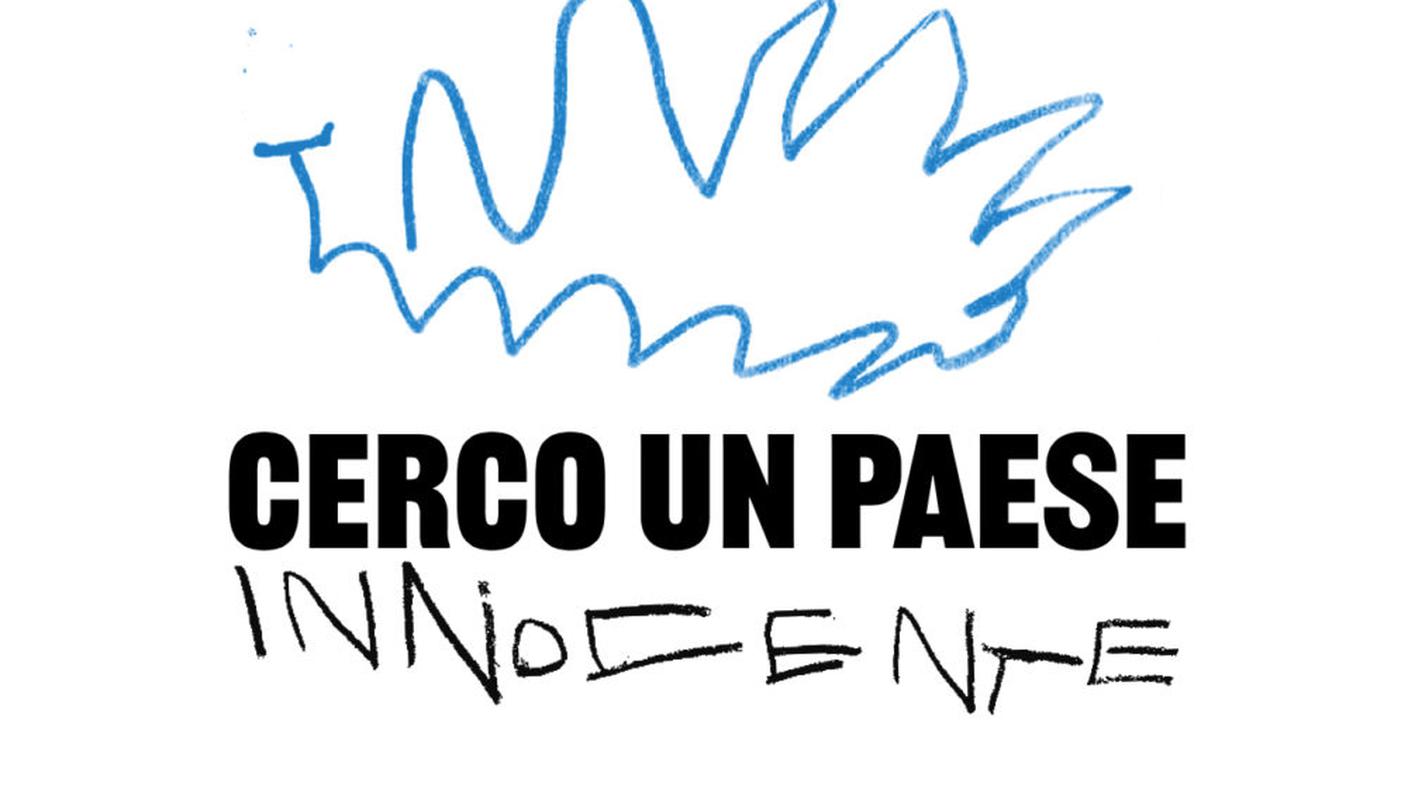Due tra i romanzi più noti di Àlvaro Mutis, L’ultimo scalo del Tramp Steamer e lo struggente Ilona viene con la pioggia – entrambi hanno come protagonisti il mare, le imbarcazioni di alto cabotaggio e i loro abitatori – possiedono quello che potremmo chiamare il pathos dell’empatia, cioè la rara capacità di proiettarci verso quelle vertigini letterarie dell’identificazione con le cose – essere cosa tra le cose, diceva Rilke – che solo la narrativa più alta riesce a raggiungere.
L’ultimo scalo del Tramp Steamer, in particolare, viaggio del corpo e del sentimento nel tempo e nello spazio, è in ultima istanza un viaggio metafisico verso le altezze della perdita e della caducità, ma anche un viaggio dentro le segrete alchimie dell’empatia. E la prosa di Mutis è così perfetta e così poetica nel rievocare le “cose” che l’empatia riconduce a noi, da consentirci di vivere tale racconto, appunto, come se non fosse solo un itinerario verso l’inesorabilità, verso il declino, verso la dissoluzione, ma con una sorta di etimologica “simpatia” nei confronti del nostro stesso destino di mortali.
Mortale, nel libro, non è però un uomo – lo è, in seconda istanza, come riflesso del vero protagonista – ma una nave-cargo, il Team Steamer, che l’Io narrante si trova a incrociare, secondo le insondabili determinazioni del caso, in tre diverse occasioni e a tre diverse latitudini. Un cargo vecchissimo, ansante, scalcagnato, sulla cui chiglia appare la scritta mutilata Alciòn e lungo i cui pontili sembra esalare l’ultimo ansito di un moribondo.
Mutis, osservandolo, ne prova subito una pietà quasi umana, l’accorata solidarietà di chi osserva, ammirandone la terminale e improbabile resistenza, il pathos stesso della finitudine di tutte le cose.
Appare dapprima a Helsinki, in uno scenario di luci e di gelo che richiama gli abissi sconsolati della poesia scandinava, e scompare poi, definitivamente, tra i gorghi del mare nel ginepraio delle isole e dei porti tropicali del Centro America.
In questo suo itinerario – rievocato nel romanzo dalle memorie del comandante basco che lo conduce – dà mostra di una voluttà di sopravvivenza che richiama la sempiterna e disumana capacità dell’umano di tenere testa alla morte. E Mutis, lungi dal farne un’occasione di panegirico o ancora peggio di peana, ne traccia simpateticamente l’agonia come se fosse al cospetto di un fratello o di un sodale dalle sembianze umane, descrivendocene il tramonto con la stessa lingua che è delle cose essenziali.
Siamo dunque al cospetto di quella che potremmo chiamare una discreta, quasi involontaria, allegoria. Laddove Mutis racconta di un’imbarcazione, racconta in realtà della condizione umana. E laddove parla dell’inesorabile consunzione di uno scafo, ci mette in realtà di fronte alla fatale condizione di declino che è insita nell’invecchiamento umano.
Ciò che più colpisce è però, appunto, lo spirito empatico con cui questa allegoria si dispiega lungo le non troppe pagine del libro. Uno spirito che fa tutt’uno con la lingua di Mutis, che non a caso, prima di essere un narratore, è stato un poeta. E cosa ci insegna intimamente la poesia – diciamo, il gesto poetico in senso largo – se non a disegnare la realtà con le parole che stanno nell’antro più profondo della realtà, a volte addirittura oltre la realtà? Cosa ci insegna la narrativa poetica, se non che la lingua, la prosa, il narrato, sono il rapporto che lo spirito intrattiene con le cose?
In questo senso in effetti Mutis e il suo L’ultimo scalo del Team Steamer sono una sorta di quintessenza del rapporto empatico che sempre il poeta – nel suo senso più esteso – intrattiene con il mondo. Lo guarda, lo osserva, nel caso del nostro povero cargo scalcagnato, in qualche modo, lo segue o lo accompagna, ma prima di ogni altra cosa lo percepisce, aderisce fino al suo ultimo lacerto di legno o ferro al suo inesorabile destino. Come un vero e proprio essere umano, ecco che il Team Steamer arranca dunque fra le onde e cerca di resistere alla consunzione, attraversa mari e oceani e si danna per mostrare le residue forme di eroismo del vecchio che non si rassegna, procede verso il suo ineluttabile tracollo ma non ci risparmia dalla commozione di ammirarne la determinazione a rimandarlo quanto più a lungo possibile.
E qui si gioca appunto lo spirito empatico e poetico di Mutis, diciamo pure la sua filosofia della pietà. Chi altro, infatti, chi altro se non un poeta che sa farsi cosa tra le cose – o ancora meglio, che sa umanizzare le cose – potrebbe avere lo stesso sguardo nei confronti di un semplice naviglio alla deriva? Melville e Conrad, nelle loro straordinarie avventure marine, posero in un modo o nell’altro le navi sempre in una sorta di retrovia dell’umano, mentre Mutis le promuove a protagoniste, a veri e propri emblemi dell’umano che le accompagna. Sono le navi ad alitare, a pensare, a volere, a sperare, a resistere, non solo gli uomini. E mai come nelle pagine del colombiamo abbiamo l’impressione che vivano, ovvero che la vita, empaticamente parlando, sia sempre e soltanto dove sappiamo individuarla e trarla alla luce.
Come dall’ombra della materia e dell’impassibilità, da sempre, la poesia e la migliore narrativa traggono alla luce l’impalpabile vita dell’umano nella sua tragica e ineffabile caducità.