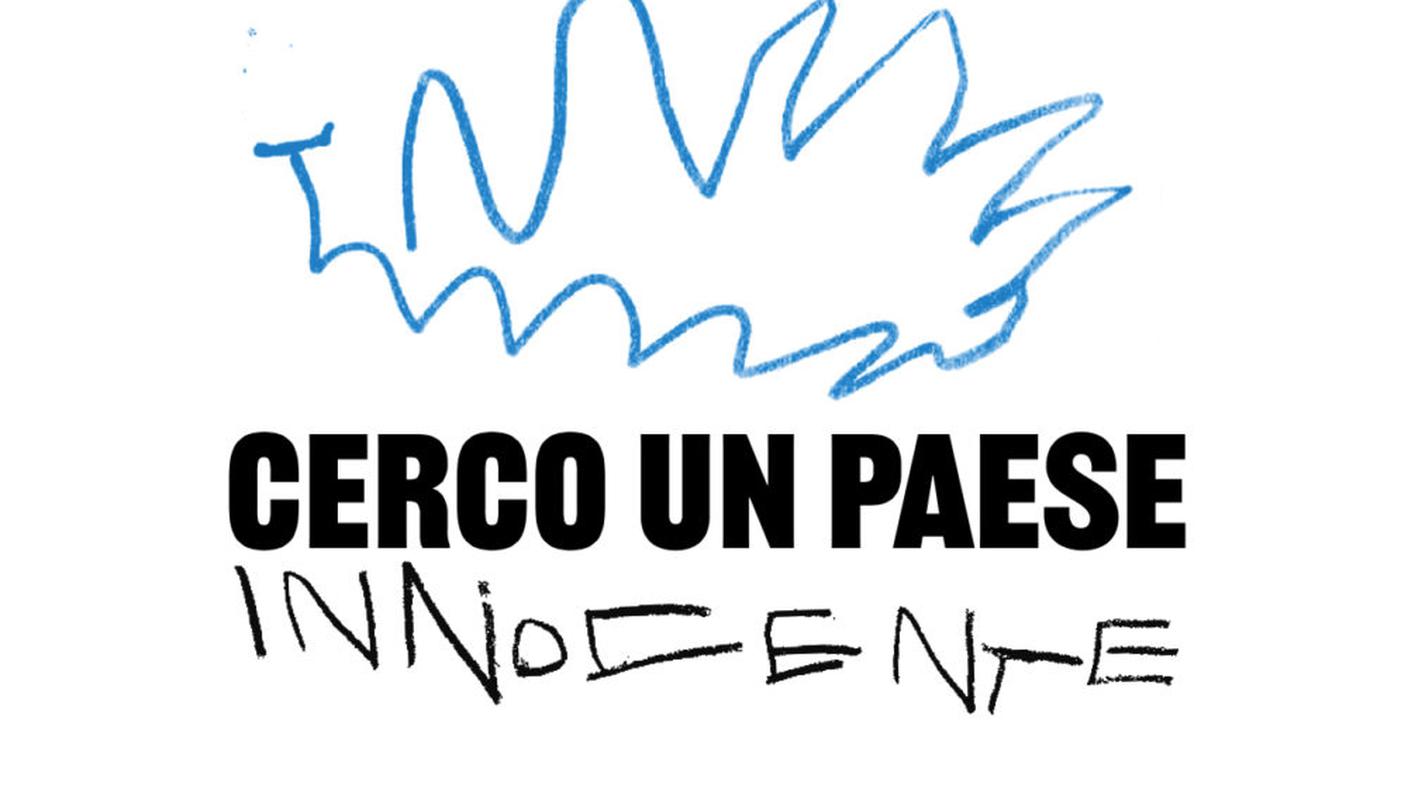C’è un ampio dibattito, in questo periodo, sul libro di Ada d’Adamo Come d’aria, vincitore del Premio Strega 2023. Un libro che i detrattori qualificano come “non romanzo” e taluni tra loro addirittura come “non letteratura”, ma che i sostenitori acclamano come “tra più intensi degli ultimi anni”. Non spetta naturalmente a noi cercare un cantuccio super partes per decidere quale dei due schieramenti abbia ragione. Ma sicuramente a una domanda non possiamo sottrarci: perché nel panorama contemporaneo italiano imperversa il gusto del “personalismo” e dell’“orrido”? Perché questa ansia collettiva di lasciarsi épater dal tragico?
La risposta è complessa e non riguarda solo quel libro. Ma quel libro è indubbiamente emblematico di un fenomeno ormai trasversale al lettorato italiano: cercare “storie vere” e sperare che siano le più “tragiche” possibile. Elementi – o ingredienti – che Come d’aria raccoglie in misura quasi smisurata, essendo l’autrice protagonista tragica della narrazione e il suo racconto la storia vera – e oggettivamente tragica – di una madre malata di tumore che partorisce una figlia soggetta a una terribile “malformazione cerebrale”. Una figlia destinata a procurare infinite sofferenze a chiunque le sta intorno, a partire dalla stessa madre e dal padre, e una madre, la medesima Ada d’Adamo, che come sappiamo al suo male non è potuta scampare, decedendo poco prima del conferimento dello Strega.
Ora, secondo una legittima lettura strettamente letteraria, molti detrattori ritengono che fare leva sulla tragedia personale – e quindi sulla pìetas – sia una scorciatoia alle “vere responsabilità della letteratura”, che in definitiva dovrebbe riconoscere il “tragico” – a partire dalla lezione di Nietzsche – laddove la vita si offre nella sua normalità. Mentre speculare su una tragedia privata che travalica l’ambito del “normale” e dell’universale – e che pertanto si presenta come tragica in sé senza nessun bisogno che lo scrittore o la scrittrice la snidi dall’ombra – è troppo comodo e non è letteratura. Posizione condivisibile, se parametriamo Come d’aria, per esempio, su capolavori quali Il male oscuro di Berto, La cognizione del dolore di Gadda o La morte di Virgilio di Broch. Ma appunto i sostenitori della d’Adamo non parametrano Come d’aria su tali opere, non si aspettano un capolavoro letterario e nemmeno lo vogliono, non cercano un romanzo o un prodotto letterario, bensì una testimonianza. E visto che la d’Adamo, oltre a essere portatrice di una duplice tragedia in sé, scrive anche con garbo e delicatezza, questa testimonianza la trovano servita in tutta la sua spietata e limpida immeditatezza.
Da qui quello che potremmo chiamare l’equivoco o addirittura il dilemma: Sono ancora, gli italiani, i lettori italiani, diciamo la maggioranza dei lettori italiani, interessati alla letteratura? Oppure sono solo interessati alle emozioni? Ed essendo maggioritariamente interessati solo alle emozioni, come potrebbero emozionarsi ancora della letteratura, a prescindere da quanto propone di orrido, scurrile, immeditamente tragico o banalmente poliziesco? Come potrebbero insomma emozionarsi di Cortázar o Jonesco, se in costoro l’emozione presuppone competenza, senso della letteratura, conoscenza filosofica e quindi intelligenza critica?
Una domanda che inevitabilmente investe anche gli editori, li chiama anzi perentoriamente all’appello: Se è vero che i libri devono anche fare cassa, vendere, raggiungere il maggior numero di lettori possibili, siamo sicuri che nell’assecondare le maggioranze, i loro gusti, le loro aspettative, la loro ansia emozionale, non stiamo diseducando il lettorato ad apprezzare la vera letteratura, ma solo le cosiddette “storie vere”, i thriller e i gialli?
La perplessità non riguarda naturalmente solo Elliot, l’editore della d’Adamo, che come sappiamo annovera nel proprio catalogo numerose e pregevolissime opere di autentica letteratura. Riguarda l’editoria e la cultura italiana in sé. Una cultura, un’editoria, una critica, una pleiade di istituzioni e premi sedicenti letterari che al mercato sono ormai costretti a subordinare ogni altro criterio, al punto di premiare qualche anno fa con il Premio Ginestra il discutibile Federico Moccia, di pubblicare e promuovere a spron battuto le leziosità di Fabio Volo, di portare alla pubblica attenzione i trascurabili romanzetti di Veltroni, Scanzi, Dandini, Littizzetto, Faletti e via elencando e di diseducare così il lettorato a distinguere tra romanzucoli d’appendice e vere opere di letteratura.
Con il risultato che oggi, di fronte al dibattito che accompagna il conferimento dello Strega alla d’Adamo, nessuno capisce più niente. Vale quanto Moravia o Bassani? Non vale niente? Non è importante se valga o non valga? Fa parte anche lei della grande melassa della produzione letteraria, dove “scrivere” e “fare letteratura” sono ormai distinzioni senza alcun importanza? Quel che è certo è che, dal momento che le stesse giurie ritengono da qualche anno “moderno” e “democratico” inserire tra i loro membri “lettori” che con la letteratura non hanno nulla a che spartire, i premi premiano ormai sulla base di criteri che di intimamente letterario hanno a loro volta ben poco.
E lo diciamo qui per un bel libro, non per un brutto libro. Del quale però, temiamo, passata la febbre empatica della pìetas, nella storia della letteratura italiana non si sa cosa rimarrà. Posto che a qualcuno, appunto, che di questo nostro antico patrimonio rimanga qualcosa importi o importerà ancora come importa a noi.