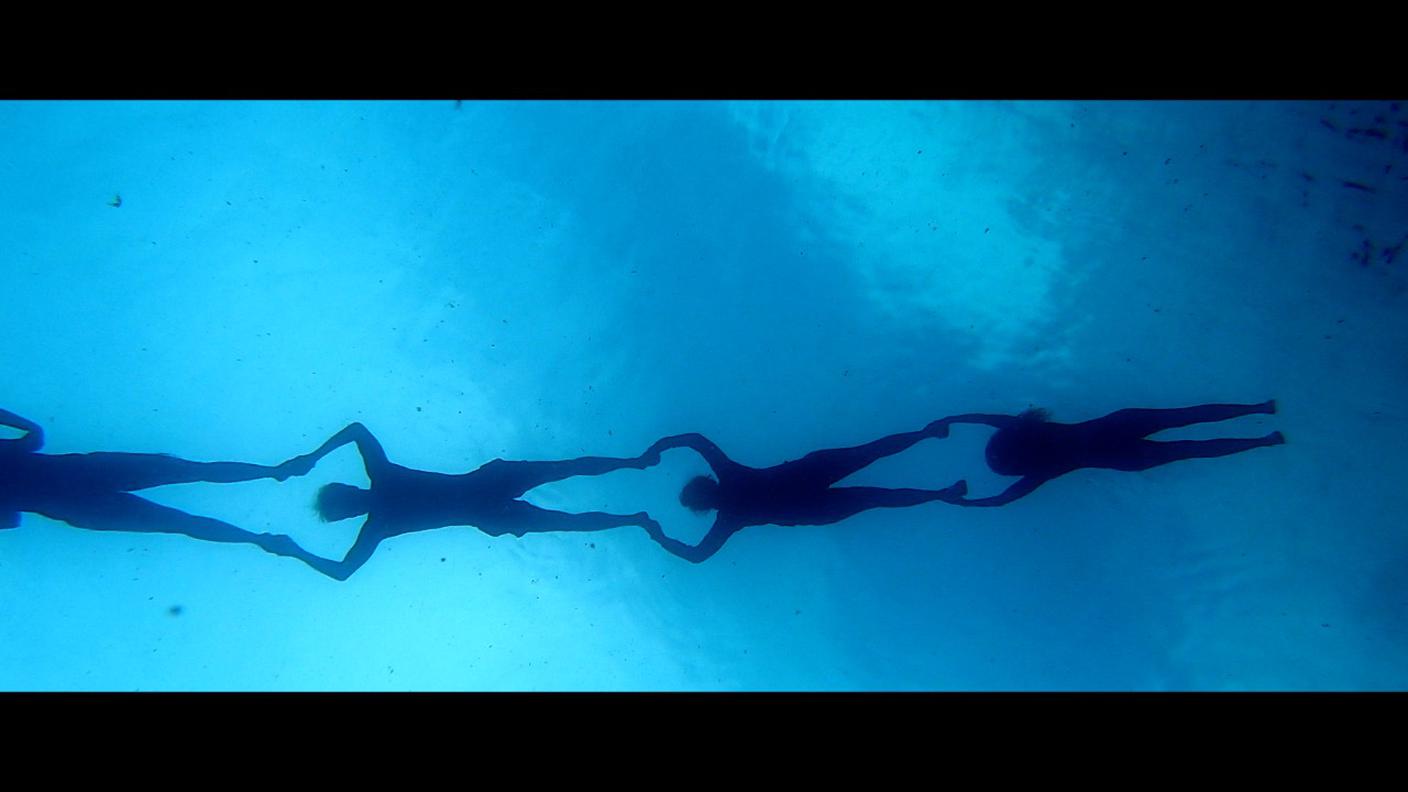«Che bravi che siete a fare il Ramadan» dicevo a mio figlio Dylan. Dieci anni, un nome portato con orgogliosa noncuranza, era al suo secondo anno di digiuno. «Io un mese intero senza bere e mangiare dall’alba al tramonto non ce la farei mai». Erano le otto di mattina. Insieme al fratello più grande Karim, Dylan si apprestava a recarsi a scuola. Fuori calcinava la strada un sole rovente: quaranta gradi fin dalle prime luci dell’alba, si annunciava un’ennesima giornata di sfibrante sacrificio. Dylan sorrise e si limitò a fare spallucce: «È il nostro dovere» commentò. E aggiunse, con fiera sincerità: «E comunque il Ramadan è bello».
Vedendolo caracollare dietro Karim giù per le scale, mi sentivo responsabile di un’educazione che, pur senza alcuna vessatoria imposizione, li aveva avviati sulla strada di un «corretto Islam», vale a dire di un Islam vissuto nella coerenza dei suoi precetti.
Quanto a me, sia Dylan che Karim lo sanno benissimo: io, da khawaga, da straniero, dell’Islam sono un perfetto abusivo. Musulmano per poter contrarre matrimonio e dare loro la luce, non ho mai professato se non un rispetto al limite dell’intransigenza per qualsiasi fede e pratica rituale. Ma nulla di quanto assomigli alla devozione in senso proprio, foss’anche al più tenue dottrinalismo, mi ha mai abitato. Questo «patto di non belligeranza» fra padre e figli mi pare uno degli aspetti più edificanti della nostra convivenza. E all’interno di tale patto il mio appello, d’altronde solo sussurrato, ad adempiere alle loro scelte in totale libertà ma seriamente. «Se volete digiunare durante il mese di Ramadan» dico spesso loro «non avrete certo in me un ostacolo. Ma se volete farlo, fatelo con dignità e senza infingimenti retorici».
Così ecco che i miei figli intraprendono il cammino della fede secondo i parametri, ad un tempo vincolanti e canonici, del loro credo e quelli, a loro modo voltairiani e libertari, del mio: assecondano gli arkan o «pilastri» dell’Islam – preghiera, professione dell’unicità di Dio, digiuno, elemosina rituale e, fra qualche anno, il pellegrinaggio – ma senza venir meno a quel dettato di responsabilità che è infine più tipico della cultura calvinistica, o weberiana, che di quella islamica. Si alzano poco dopo le otto, rimangono a digiuno per l’intera giornata, si coricano intorno alle undici di sera, si svegliano per consumare il pasto (dhuhur) che precede l’alba, intorno alle tre di notte, poi tornano a dormire fino al risveglio. Tutto, esattamente o quasi, secondo le prescrizioni coraniche.
O quasi, già. Perché a rigore il digiuno di Ramadan dovrebbe delinearsi secondo regole ancora più rigide: a ridosso del dhuhur il risveglio definitivo e poi una lunga giornata di lavoro, o di scuola, senza nessuna concessione al sonno. E solo dal tramonto all’alba la possibilità di ristorarsi dormendo. Insomma, un digiuno da desti e non da dormienti. Un digiuno talmente radicale che, soprattutto nei lunghi mesi estivi, sfiora veramente l’immolazione. Ma quanti sono i musulmani ligi a una simile assunzione alla radice dei precetti coranici? Certamente una ridottissima minoranza. Per la più parte di loro, laddove il lavoro lo consente, la prassi è viceversa quella di attenuare al massimo i contraccolpi del digiuno: dormire quanto più a lungo possibile dall’alba al tramonto, ingerire quanto più cibo e liquidi prima di coricarsi, magari ad alba ormai ampiamente inoltrata, e laddove gli impegni di lavoro non lo impediscano ritagliarsi ogni margine di tempo libero per sprofondare nel sonno e alleviare così le fatiche della fame e della sete.
Stratagemmi legittimi, per carità. Chi abbia anche solo per un giorno provato i patimenti del digiuno – soprattutto a queste temperature – sa che una soverchia serietà confina con il fanatismo e il pathos martiriologico. Ma detto questo non nascondiamoci dietro un dito: aggirare nel sonno il gravame del digiuno non è espressione di grande responsabilità. E forse i miei figli questo l’hanno imparato proprio dal meno devoto dei genitori: l’etica non ha cittadinanza nel cosa di una dottrina ma nel come la si applica. Il valore di un credente e di un non-credente si ritrovano nella serietà.