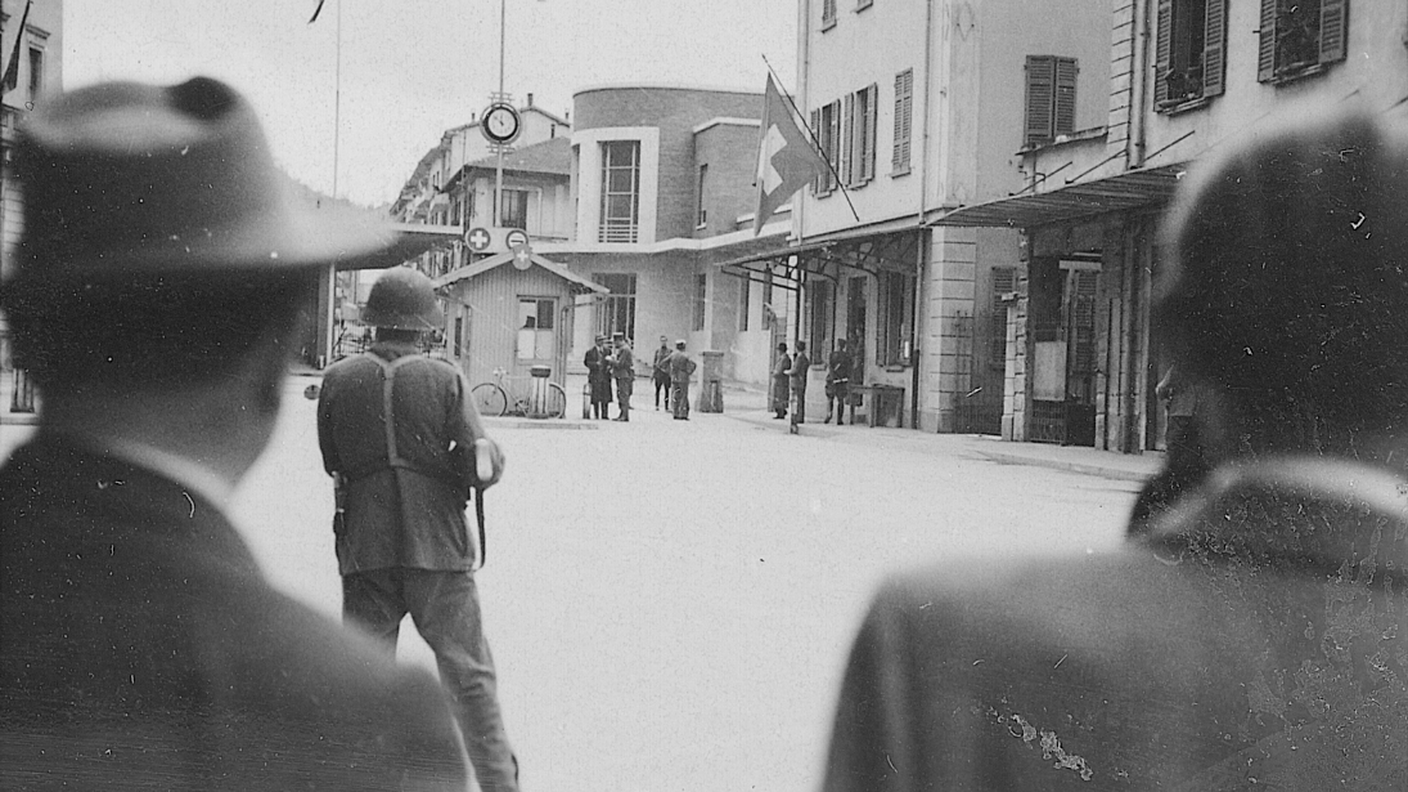Nell’ambito della Guerra svizzera dei contadini (1653) queste furono le figure più rappresentative e vennero identificate con il nome di Tre Tell. In effetti, durante proprio in quel conflitto un ruolo fondamentale fu giocato dal ricordo legato alla figura di Guglielmo Tell e dei Miti di fondazione, una memoria collettiva che sostenne i ribelli emotivamente, cosicché potessero diffonderne la forza sovversiva, concretizzando e legittimando persino l’idea radicale di un cambiamento (rivoluzionario) del potere costituito. Come indicato dall’archivista scientifico dell’Archivio di Stato del Canton Lucerna Gregor Egloff nel testo a loro dedicato, i tre Tell si traducevano nei lucernesi Hans Zemp e Kaspar Unternährer e Ueli Dahinden, apparsi per la prima volta a Schüpfheim nel febbraio del 1653 abbigliati con costumi storici donati dall’alfiere Hans Emmenegger, personificando così i tre “primi Confederati”, ossia Walter Fürst, Arnold von Melchtal e Werner Stauffacher (che dal Cinquecento si confusero con il personaggio di Guglielmo Tell, divenendo appunto “I tre Tell” nelle rappresentazioni popolari dell’epoca).
In occasione di svariati incontri organizzati dai contadini, questi nuovi difensori del popolo si rivelarono dunque importanti figure di integrazione, al pari di altri simboli quali ad esempio la mazza ferrata (arma con aculei di metallo utilizzata nei combattimenti corpo a corpo); allo scoppio della guerra dei contadini questo simbolo d’unione personificò così il fondamentale passaggio da semplice sudditanza ad antagonisti emancipati dell’autorità, che non giungevano più per elemosinare, ma piuttosto per pretendere, fornendo linfa nuova e propulsiva alle Rivolte contadine. Un esempio della forza di queste figure la si trova proprio nella vicenda dell’ambasciatore della città di Lucerna Ulrich Dulliker il quale, dopo aver ricevuto il giuramento dei sudditi dell’Entlebuch, venne ferito in un attentato ordito dai Tre Tell, che appunto reclamavano la «Libertà elvetica» anche per i ceti popolari lucernesi e non soltanto per il patriziato urbano.
Per comprendere le ragioni della nascita di questo nuovo simbolo di ribellione bisogna comunque tornare anche all’anno che precedette lo scoppio della guerra dei contadini: come sottolinea lo storico Francesco Cerea nel suo contributo “La contestazione agli eredi di Tell. Conflitti sociali nei cantoni democratici del XVIII secolo” (Norma e Contestazione nel XVIII Secolo, pp.321-332), fu in quel momento che gli ambasciatori dei Cantoni cattolici giurarono a Torino il rinnovo d’alleanza con il duca Carlo Emanuele II di Savoia. Una delle clausole di questa alleanza prevedeva proprio l’imposizione ai sudditi dell’obbligo d’obbedienza verso i rispettivi sovrani (sia di tipo monarchico, sia repubblicano), che a loro volta si sarebbero garantiti vicendevolmente in caso di disordini, come appunto successe proprio nella guerra dei contadini del 1653. Qualora i Cantoni cattolici non fossero riusciti infatti a placare autonomamente l’instabilità politica causata dai tumulti dei propri sudditi, in base al rinnovamento d’alleanza del 1652 il duca di Savoia avrebbe potuto teoricamente intervenire in soccorso degli alleati, legittimando potenzialmente un’invasione del territorio elvetico con lo scopo di ristabilire l’ordine costituito. L’anno successivo, dunque, nel tentativo di sedare la rivolta già deflagrata alcuni mesi prima dell’atto di lesa maestà (che appunto aveva visto l’attentato dello scoltetto Ulrich Dulliker, uno degli ambasciatori della città di Lucerna recatosi a Torino), Lucerna aveva avvisato i suoi alleati confinanti che inviarono in suo soccorso le truppe dei Cantoni cattolici agli ordini di Sebastian Peregin Zwyer von Evibach, anch’egli uno degli inviati di Uri in occasione del rinnovo dell’alleanza a Torino con Carlo Emanuele II. Per aver salvato il Cantone, il condottiero venne successivamente ricompensato dal governo aristocratico con una catena d’oro, una medaglia commemorativa e la cittadinanza onoraria di Lucerna.
Sebastian-Peregrin Zweyer d’Evebach, incisione tratta dai Tableaux de la Suisse, Parigi 1780-1788.
Per sedare le turbolenze dei contadini del 1653, alla richiesta di soccorso degli alleati rispose anche il nidvaldese Peter Zelger (anch’egli ambasciatore a Torino per il suo cantone), landfogto di turno a Lugano. Egli dispose un contingente dal baliaggio ticinese verso la Svizzera centrale, un atto che ben esemplifica come le autorità impiegassero “sudditi utilizzati militarmente contro altri sudditi” a seconda delle loro necessità del momento, in una dinamica presente nell’antica Confederazione e per tutto il XVIII secolo, come ad esempio anche nella rivolta della Leventina. Ciò detto, per lo storico Cerea le figure di Dulliker, Zelger e Zweyer dimostrano come la solidarietà e l’interconnessione di molti esponenti del ceto dirigente elvetico fosse profonda, a prescindere dalla costituzione aristocratica o democratica del rispettivo Cantone d’origine. E il viaggio alla corte di Torino del 1652 fu un evento utile proprio al rafforzamento della loro coesione, in un’ideologia che permettesse di percepirsi e comportarsi come un’élite scelta direttamente da Dio per difendere la cattolicità e per governare le rispettive repubbliche, proprio come i duchi di Savoia si percepivano rispetto ai loro dominii ereditari. In questo senso è da intendersi, sempre secondo Cerea, anche l’arringa barocca declamata durante il giuramento d’alleanza alla presenza di Carlo Emanuele II, quando allegoricamente si alluse proprio a questo legame: «Così piaccia al Sig.re che seppe unire et collegare con vincoli di Cristiana carità, et à commune difesa i vostri fasci consolari a questo scettro regale».
La guerra dei contadini si concluse con una violenta repressione, i capi-banda furono puniti in modo esemplare così da dissuadere i ceti popolari da qualsiasi futura ambizione di autodeterminarsi politicamente mediante Landsgemeinde (prerogativa esclusiva di coloro che già utilizzavano questa forma di governo da secoli). Non a caso, dunque, per quanto riguarda I Tre Tell, se da un lato Unternährer e Dahinden fino alla fine giocarono un ruolo di primo piano quali capi dei rivoltosi, il terzo Tell, Hans Zemp, si rifugiò invece in Alsazia dove rimase fino al 1654, con l’obiettivo di evitare di subire la stessa linea dura che adottarono le autorità lucernesi dopo la repressione della ribellione. In effetti, come afferma ancora Gregor Egloff, i patrizi non solamente respinsero l’idea di un’amnistia nei confronti dei vertici ribelli fuggiti, ma isituirono addirittura un regolare giorno del giuramento al balivo cittadino proprio a Schüpfheim (il cui scopo era quello dimostrare la continuità e la normalità dell’amministrazione), diventando dunque impossibile per i capi dei contadini ritornare all’ambita vita che conducevano prima della guerra dei contadini. Questo fatto, unitamente alla frustrazione per la sconfitta delle rivolte rurali, portò poi alla radicalizzazione di un gruppo di insoddisfatti e così, nonostante gli accadimenti, fu architettato l’assassinio dello scoltetto di Lucerna, rappresentato in modo inequivocabile quale “tiranno”. In un’imboscata, Dahinden, Unternährer e Hans Stadelmann (che rimpiazzava Zemp, sempre in Alsazia) uccisero allora l’intendente dell’arsenale di Lucerna Caspar Studer, e ferirono appunto Dulliker. Il gesto simbolico degli attentatori venne subito compreso dal popolo, guadagnando così un sempre più ampio consenso; tuttavia questo atto non fu sufficiente per sostenere una nuova rivolta, in quanto l’idea di un’insurrezione collettiva aveva sempre meno seguaci, cosicché l’attentato non solo fu un evento eccezionale sul territorio della vecchia Confederazione, ma fu anche inutile sul piano politico. Ciononostante, il gesto si avvolse di un valore morale e civico per il quale la tirannia non venne abolita, ma fu comunque smascherata davanti agli occhi di tutti, o perlomeno questo fu quello che i tre Tell (e ampia parte della popolazione) credettero. Con l’ingresso delle truppe lucernesi comandate dal colonnello Alphons von Sonnenberg, i ribelli persero però ogni sostegno e, all’inizio di ottobre del 1653, Dahinden e Unternährer vennero uccisi dopo un breve scontro a fuoco; nel giugno del 1654 fu poi lo stesso Zemp a consegnare alle autorità il suo sostituto Stadelmann (giustiziato nel luglio del 1654), in cambio della grazia.
I Tre Tell in una scultura posta sul tetto della nave passeggeri verso il prato del Rütli.
Malgrado la vicenda dei tre Tell lucernesi ebbe un epilogo insoddisfacente, l’archivista Egloff sottolinea che venne comunque mostrata l’esistenza di unioni molto forti tra i movimenti rivoltosi locali, attuati in diversi Cantoni attraverso la diffusione sovraregionale del cosiddetto Tellenlied e della sua simbologia. Nei Freie Ämter e nell’Emmental comparvero in effetti delle personificazioni dei tre Tell: personaggi che rappresentarono l’aspettativa e la fede che quel successo ottenuto dai loro ideali predecessori potesse ripetersi.
Il racconto più recente, attestato dal 1796 e analogo alla leggenda di Federico I Barbarossa (o del Kyffhäuser), secondo cui i tre Tell si erano assopiti in una caverna ai piedi del Rigi, è fondato sull’immagine coeva del Tell dormiente, il cui ritorno, già evocato nel Tellenlied del 1653, aveva avuto simbolicamente luogo con i Tre Tell (Gregor Egloff, paragrafo estratto dal Dizionario Storico della Svizzera)
1307. Guglielmo Tell
Altri Programmi 20.06.2024, 07:00